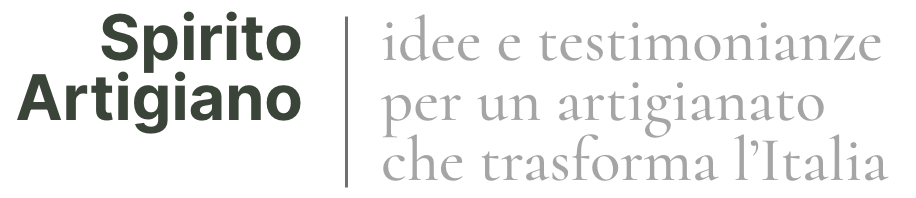Qualche tempo fa il New York Times ha pubblicato un lungo e toccante articolo su un manager, Paul Lundy, che a Seattle stava “vivendo la lenta morte del lavoratore sotto le luci fluorescenti” di un lavoro stabile nel mondo corporate, lasciato per dedicarsi alla riparazione di macchine da scrivere, imparando un mestiere dato per estinto a fianco di un artigiano anzianissimo, la cui bottega ha poi rilevato.
Nel gesto lento, preciso e ripetibile della manutenzione meccanica ritrova una forma di senso che il lavoro astratto aveva smarrito. La tecnica, qui, non è nostalgia ma conoscenza incarnata, rapporto diretto con la materia e con il tempo. È artigianato come pratica concreta di significato, in un’epoca che fatica a produrne.
Non è certamente quello di Paul Lundy, e della trasformazione del suo lavoro da immateriale a prettamente analogico e materiale, un caso unico, tutt’altro. Ritengo invece rappresenti l’avanguardia di una reazione allo spiegamento della geometrica potenza — e violenza — della tecnologia come fatto unicamente esponenziale e disumanizzante, che ha già da tempo sottomesso la gran parte del lavoro immateriale e ora avanza rapida e indomabile per conquistare ogni ambito del lavoro.
Quanto più rapidamente e pervasivamente si sviluppano soluzioni tecnologiche — su tutte un certo uso dell’intelligenza artificiale — che marginalizzano il contributo umano; quanto più il lavoro smaterializzato e l’economia a propulsione finanziaria consentono e incentivano la polverizzazione del lavoro e l’idea dei lavoratori come variabile sostituibile; tanto più torna ad essere sensata e competitiva l’idea che il lavoro manuale, e il suo patrimonio peculiare di tecnica e competenze, possano tornare ad essere una prospettiva concreta per molti.
Non parliamo solo di giovani in cerca di un futuro lavorativo di fronte alle mille promesse senza costrutto di un mercato della formazione in cui il termine “mercato” ha sottomesso la missione di “formare”, né delle aspettative, spesso fragili, delle famiglie, che continuano a preferire un figlio avvocato a uno elettricista, quando le professioni legali sono oggi — e saranno sempre più — in crisi per sovrappiù di risorse, scarsa redditività e sostituibilità tecnologica. Dire ai giovani che dovrebbero considerare un mestiere manifatturiero e artigiano, ovviamente declinato in modo contemporaneo e con una forte componente tecnologica, è necessario ma non sufficiente.
La demografia inclemente, che ci vede come secondo Paese più anziano al mondo e fortunatamente tra i più longevi, ci dice che il tema del lavoro “anziano” — o, più ottimisticamente, delle molteplici vite professionali nel corso di un’esistenza longeva — comincia a occupare la pubblicistica più attenta a livello globale. L’idea che una di quelle vite, magari alla fine di una più o meno gloriosa carriera dietro una scrivania, possa essere dedicata al “fare”, apprendendo tecniche (altro verbo fondamentale in una vita longeva) e applicandole per produrre beni e servizi non comprimibili, non inscatolabili, non delocalizzabili perché basati sulla relazione umana e sulla pienezza del senso, è tutt’altro che marginale. Così umani da accogliere — eresia per i tecnofili — l’imperfezione e la limitazione come sanità, non come aberrazione. Penso al ritorno, ormai da qualche tempo, degli LP in antitesi alla musica digitale, e a quello più recente della fotografia analogica non solo come tecnica per una ristretta conventicola, ma come mezzo “umano” di espressione.
Sono tutti segni, non di massa ma certamente di avanguardia, di un bisogno diffuso di rimettere al centro, come persone, i processi sociali, produttivi ed economici. Andiamo qui oltre la vecchia idea di “lusso” ed “eccellenza” riservata a pochi che comprano le mani sapienti: anche questo è ormai un concetto obsoleto e debole. Siamo di fronte, a partire dall’Europa e da ciò che rimane di più sano degli Stati Uniti, a un modello di organizzazione sociale, del lavoro, della produzione e dei consumi che non ci lasci assetati dopo aver bevuto, come accade oggi.
È un’occasione irripetibile per chi, come il movimento artigiano, ha sempre creduto in questa idea paziente e generativa dell’economia, spesso come voce nel deserto ai tempi della disruption. Ora forse qualcosa sta cambiando: a noi rivendicare la forza del nostro modello peculiare come buono, pulito e giusto.
© Spirito Artigiano 2026. Tutti i diritti riservati.
Paolo Manfredi
Milanese, 50 anni. È consulente per la Trasformazione digitale, ideatore e responsabile del progetto Artibici e responsabile del Progetto speciale PNRR di Confartigianato Imprese. Ha studiato Storia contemporanea. Scrive di innovazione, politica e ristoranti. È autore di “L’economia del su misura. Artigiani, innovazione, digitale” (2016), “Provincia non Periferia. Innovare le diversità italiane” (2016) e di “L’eccellenza non basta. L’economia paziente che serve all’Italia” (2023). Da settembre 2019 cura il blog “Grimpeur. Scalare la montagna dell’innovazione inclusiva” sulla pagina web di Nòva del Sole 24 Ore.