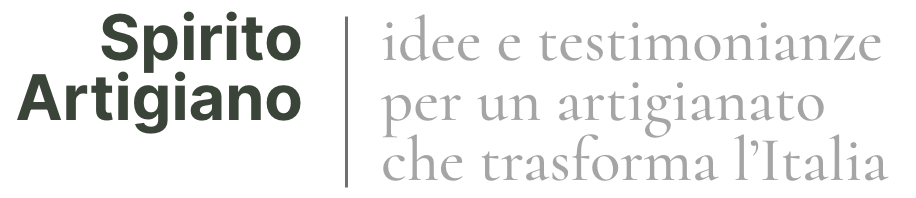Siamo dentro una trasformazione strutturale destinata a cambiare tanto gli equilibri politici quanto gli assetti economici. Nessuno sa esattamente quello che accadrà. Ma certamente tra 10 anni ci accorgeremo che si saranno create nuove gerarchie a livello planetario. Ci saranno vincitori e sconfitti.
L’Italia – che è stata molto marginale nei processi della stagione della globalizzazione espansiva perdendo gran parte dello smalto che l’aveva portata tra i primi 7 Paesi industrializzati – si trova ora davanti a un nuovo bivio: da un lato il definitivo declino. Uscire passo dopo passo dal novero dei Paesi più avanzati trascinata verso il basso dai due grandi deficit strutturali che ereditiamo dagli ultimi trent’anni: quello demografico e quello finanziario.
Oppure – ed è questa l’opzione che deve essere perseguire con l’ottimismo della volontà ma anche con l’intelligenza visionaria – saper cogliere nella nuova stagione che sta per nascere l’occasione per il rilancio del nostro paese. Obiettivo raggiungibile a condizione di sapere interpretare gli elementi costitutivi del prossimo futuro – e cioè sostenibilità e digitalizzazione – sulla base del codice che ci caratterizza.
Tema non facile che per un Paese così particolare come l’Italia si ripropone ogni volta in cui cambiano i grandi cicli storici.
Il tema del Made in Italy – tornato alla ribalta anche per la decisione del governo Meloni di fare un riferimento esplicito alla questione nella nuova compagine ministeriale – ha in realtà a che fare con questa biforcazione.
Vorrei qui sottolineare due aspetti che trovo qualificanti.
“L’Italia sa tenere polifonicamente unite la “sapienza dei luoghi” (il genius loci) e la sapienza delle pratiche”
Il primo riguarda il rapporto tra universale e particolare. Se c’è un tratto che caratterizza il nostro Paese – e che si traduce poi in fattore di competitività economica – è la sua capacità di mettere a sintesi l’esperienza particolare, con la pluralità e l’alterità delle stesse esperienze. Capacità che gli permette di tenere polifonicamente unite la “sapienza dei luoghi” (il genius loci) e la sapienza delle pratiche. E di rendere entrambe una “forza” universale e universalizzante (che cioè si traduce in tradizione e tensione etica) così da rigenerare continuamente il presente. L’Italia è ricchissima di esempi di questa “universalità incarnata”. Lo sanno i turisti stranieri, che trovano qui qualcosa di unico, che non incontrano altrove. Nell’arte, nell’urbanistica, fino alle tradizioni culinarie, spesso sviluppate a partire da situazioni di penuria, ma capaci di realizzare stupefacente valore. Una delle caratteristiche del genio italico è infatti proprio la capacità di rovesciare il limite in risorsa, lo scacco in stimolo, attingendo da forze che eccedono la situazione, per superarne i limiti in modo generativo. In questo modo, il nostro modello mantiene virtù che altrove mancano: la vocazione all’apertura e all’accoglienza, la valorizzazione dei rapporti umani, il gusto estetico, la capacità di coniugare il particolare e la comunità locale con l’universale. La forza economica dell’Italia attinge a questo patrimonio culturale le energie vitali che la spingono avanti.
“Tuttavia il modello italiano ha anche generato virus che ne hanno minato la sopravvivenza: una certa resistenza al cambiamento e all’innovazione; il familismo amorale; corporativismi, localismi e campanilismi regressivi”
Tuttavia il “modello italiano”, da molto tempo subalterno rispetto a quelli vincenti di matrice anglosassone o nordica, ha anche generato virus che ne hanno minato la sopravvivenza: una certa resistenza al cambiamento e all’innovazione; il familismo amorale, in cui a prevalere sono le relazioni parentali e non le competenze; corporativismi, localismi e campanilismi regressivi. Da qui consegue una prima considerazione: il made in Italy è un modello molto raffinato che si basa fondamentalmente sulla condivisione di una cultura e su un adeguato livello formativo (civile e professionale), due elementi necessari per far brillare le caratteristiche distintive che lo rendono interessante e competitivo. Al contrario, quando si culla della propria particolarità e si chiude nel particolarismo tale modello fallisce. Ed è il gioco difficile tra la cura della propria particolarità e la capacità di essere all’altezza dei tempi che si ripropone in questo passaggio storico.
Di sicuro, il modello italiano riesce a esprimersi quando riesce ad accedere in modo adeguato al codice tecnologico che caratterizza una determinata epoca. È oggi siamo nel pieno della trans kind digitale destinata a cambiare in profondità il nostro modo di produrre, di vivere, di pensare. Per accedere al futuro è dunque necessario un investimento massivo nelle nuove tecnologie, accompagnato – però – da un impegno persino maggiore nella formazione. Pratica e non solo teorica. Tema che tocca il mondo della scuola e dell’università ma che interessa anche il mondo delle imprese: come far transitare un modello produttivo che rimane predigitals nella nuova cornice tecnologica senza perdere quella maestria “artigiana” che lo caratterizza?
“Oggi si deve lavorare per ricreare le precondizioni sociali culturali istituzionali ambientali che rendono possibile la stessa crescita”
Il secondo aspetto ha invece a che fare col mutamento della logica stessa che sottende la crescita economica. In questa nuova fase – instabile e turbolenta – è chiaro che la crescita economica non si da più “a prescindere” come nella fase della globalizzazione espansiva. Oggi si deve lavorare per ricreare le precondizioni sociali culturali istituzionali ambientali che rendono possibile la stessa crescita. È il tema della sostenibilità intesa nella sua accezione più ampia.
Anche in questo caso il modo italiano ha alcune predisposizioni che teoricamente lo possono avvantaggiare. Che il profitto economico possa essere un valore condiviso e di relazione, vincolato al territorio e alla sua rigenerazione è qualcosa che fa da sempre parte della nostra storia economica. Dall’epoca dei monasteri medievali, primi nuclei produttivi “di territorio”, fino all’impresa di comunità di Olivetti, passando per il fitto tessuto del mondo artigiano e le esperienze di welfare aziendale targati Marzotto o Falck. Tutti casi in cui è difficile tracciare un confine netto tra il valore prodotto per l’impresa e quello che va a beneficio dei territori. Perché la nostra – italiana e mediterranea in senso lato – è una storia fatta da città e Comuni, e poi da imprese familiari e territori, e infine da aziende (grandi e piccole) e distretti. La via italiana al fare business ha questo di peculiare: il legame, a volte difficile ma sempre vivo, tra fabbrica e attori del territorio. Un’osmosi ad alta intensità di scambi, di relazioni, in cui efficienza ed efficacia sociale non sono mai (troppo) divaricate.
Separare il profitto delle società dal benessere delle comunità – cioè dividere shareholder e stakeholder – ha radici culturali che affondano altrove. È un’operazione che replica sul piano imprenditoriale e sociale il dualismo irrinunciabile tra città di Dio e città dell’uomo che ispira la riforma Calvinista e che si innesta sui territori a confessione protestante. Ma che è estraneo alla cultura cattolica che permea la penisola.
Se business is business, ed è addirittura criterio per essere “prescelti” dall’alto, quel che resta all’impresa in termini di responsabilità sociale è relegato a un “secondo tempo”, quello della filantropia, una sorta di restituzione ex post di parte del valore prodotto e interamente, legittimamente goduto dallo shareholder. è anche per queste ascendenze culturali che il mondo anglosassone vive la competizione come valore preminente tra le imprese e nelle imprese e questo genera grandi istituzioni di charity.
Il modello italiano – caratterizzato dalla piccola impresa e soprattutto dalla presenza artigiana – lega nella sua stessa struttura produttiva l’impresa col territorio
In sintesi e andando per generalizzazioni (e inevitabili approssimazioni): l’idea di fare business separa efficienza ed efficacia sociale, perseguendo un modello di business che assume l’efficienza come valore a oltranza, mitigato dalla “riparazione filantropica”. Il modello italiano invece – caratterizzato dalla piccola impresa e soprattutto dalla presenza artigiana – lega nella sua stessa struttura produttiva l’impresa col territorio. Tra il singolo produttore e il contesto non c’è soluzione di continuità. L’uno e l’altro vivono e cadono insieme. Anche se, è bene ricordare, questo legame va continuamente rigenerato, non può essere dato per scontato. E tantomeno in una fase come quella che stiamo vivendo con i drammatici passaggi che la caratterizzano.
Quando si parla di Made in Italy oggi è dunque necessario condividere un percorso che recuperi nei fatti il valore della “comunità ecologica”, del nostro essere comunità (piuttosto che del nostro avere una comunità). Che ricerchi e valorizzi poliarchie che facciano di nuovo respirare la democrazia e irrobustiscano l’economia nella giustizia. Provando a immaginare e realizzare percorsi imprenditoriali che immettano nel sistema elementi e alternative a intensità diversa, cioè ingredienti partecipativi, distribuiti su tutta la catena del valore. Ma dire questo significa avere in mente un’idea diversa dal modello che verticalizza, standardizza, individualizza. Magari in nome della sostenibilità ambientale, che rischia di diventare un nuovo cavallo di Troia per imporre modelli radicalmente diversi.
Non ce lo si può nascondere. Parlare di Made in Italy significa avere il coraggio di combattere una battaglia contro i nemici interni e i detrattori esterni. A cominciare da ricreare un nuovo legame tra sviluppo locale e risparmio privato, riducendo l’impatto della catene del valore finanziario che rispondono a criteri di altra natura.
Una sfida bellissima che l’Italia può e deve vincere.
Foto di Kelly
Mauro Magatti
Laureato in Discipline Economiche e Sociali all'Università Bocconi di Milano e Ph.D. in Social Sciences a Canterbury, è professore ordinario all’Università Cattolica di Milano. Sociologo, economista ed editorialista del Corriere della Sera, membro della Commissione Centrale di Beneficienza della Fondazione Cariplo, del Comitato per la Solidarietà e lo sviluppo di Banca Prossima e del Comitato Permanente della Fondazione Ambrosianeum. Dal 2008 è direttore del Centro ARC (Anthropology of Religion and Cultural Change)