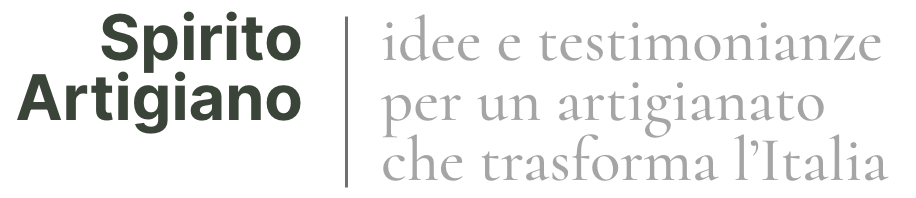Che il lavoro stia cambiando profondamente è cosa ormai nota, non c’è giorno senza che vengano raccontate trasformazioni, piccole o grandi, o senza che non si pongano criticità date dal venir meno di modelli ai quali eravamo abituati.
Spesso ci si concentra molto sul tema della tecnologia, lasciando sullo sfondo altri macro-trend che paiono invece più dirompenti. Un esempio è il fatto che, ormai da qualche anno, nelle economie sviluppate ci sono due fenomeni, apparentemente in contraddizione, sembrano dominare il panorama del mondo del lavoro.
Il primo è il calo demografico che caratterizza i paesi occidentali, ormai osservato da almeno trent’anni ma che nell’ultimo decennio appare molto più marcato.
Se prendiamo il caso italiano il trend pare ormai irreversibile essendo, già dal 2020, insufficiente anche l’apporto della popolazione straniera nel mantenere positivo il saldo netto tra nascite e morti. Un trend del quale solo negli ultimi anni si stanno manifestando le prime conseguenze, che però quasi mai vengono connesse a questa causa. Pensiamo solo alla continua denuncia da parte del sistema imprenditoriale dell’assenza di forza lavoro, soprattutto in alcuni settori e di come questo non venga quasi mai messo in relazione a una assenza ormai strutturale di persone causato dallo svuotamento delle coorti anagrafiche più giovani negli ultimi decenni.
Il secondo è un fenomeno che è molto più difficile da quantificare, al contrario di quello demografico, e intorno al quale il livello di demagogia, o meglio di narrazione edificante o demolente che sia, rende difficile tracciare confini chiari.
“Gli effetti dirompenti del calo demografico e del quite quitting”
Qualcuno lo riduce alla crescita osservata di dimissioni, o piuttosto di turnover dei lavoratori da impresa a impresa. Altri osservano un diverso atteggiamento nei confronti delle attività lavorative, parlando di quite quitting per identificare il fenomeno che porterebbe i lavoratori, per un insieme variegato di cause, a ridurre al minimo il proprio lavoro così da essere adempienti unicamente a quanto previsto dalle mansioni contrattuali, senza alcun coinvolgimento ulteriore.
Altri ancora si concentrano su una rinata attenzione, spinta anche dal grande sconvolgimento di priorità e di abitudini portato dal Covid-19 e in particolare dai lockdown, alla vita privata, vista in contrapposizione rispetto al lavoro. In generale, senza voler ridurre ad aspetti specifici che altro non sono se non manifestazioni sintomatiche di una diagnosi più complessa, si può parlare di una crisi del senso del lavoro contemporaneo.
“Da un lato avremo (e abbiamo) sempre meno lavoratori a causa delle trasformazioni demografiche e, dall’altro, è sempre più complesso coinvolgere e motivare i pochi che ci sono”
L’insieme di questi due fenomeni è dirompente. Da un lato avremo (e abbiamo) sempre meno lavoratori a causa delle trasformazioni demografiche e, dall’altro, è sempre più complesso coinvolgere e motivare i pochi che ci sono.
All’interno di questo doppio movimento si gioca il futuro delle imprese e dei modelli organizzativi e di gestione delle risorse umane.
Qui rientrano, con un occhio nuovo e una prospettiva diversa dal passato, tutte le tematiche connesse alla conciliazione tra vita e lavoro intesa non solo come piccoli accorgimenti organizzativi ma come prospettiva olistica di sostenibilità del lavoro.
In quest’ottica la riflessione, ad esempio, sullo smart working non può limitarsi ad essere ridotta al mero eseguire la prestazione lavorativa da un luogo all’altro, ma occasione per ripensare soprattutto ai tempi di lavoro, all’attualità o meno oggi dell’ora-lavoro come unico parametro organizzativo e di costruzione della retribuzione. Le persone chiedono autonomia e modelli organizzativi più flessibili, e sono disposte ad essere valutate, soprattutto i giovani, sui risultati che portano chiedendo che tali risultati non siano parametrati unicamente al numero di ore che vengono lavorate, ma agli obiettivi raggiunti.
Per questo le imprese hanno oggi la priorità dell’ascolto dei loro collaboratori, occorre fermarsi e capire in che direzione sta andando il mondo, perché l’accelerazione è stata forte e il rischio di essere spaesati è alto.
Francesco Seghezzi
Presidente di Fondazione ADAPT e assegnista di ricerca presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. PhD in Formazione della Persona e Mercato del lavoro. ADAPT Senior Research Fellow e Visiting scholar presso la Catholic University of America, Visiting Fellow alla Industrial and Labour Relation School della Cornell University e Visiting Fellow presso la University of Chicago. Tra i suoi temi di ricerca la sociologia del lavoro e le relazioni industriali con particolare attenzione alla fascia giovanile e territoriale, e al rapporto tra lavoro e innovazione tecnologica. Editorialista presso diverse testate