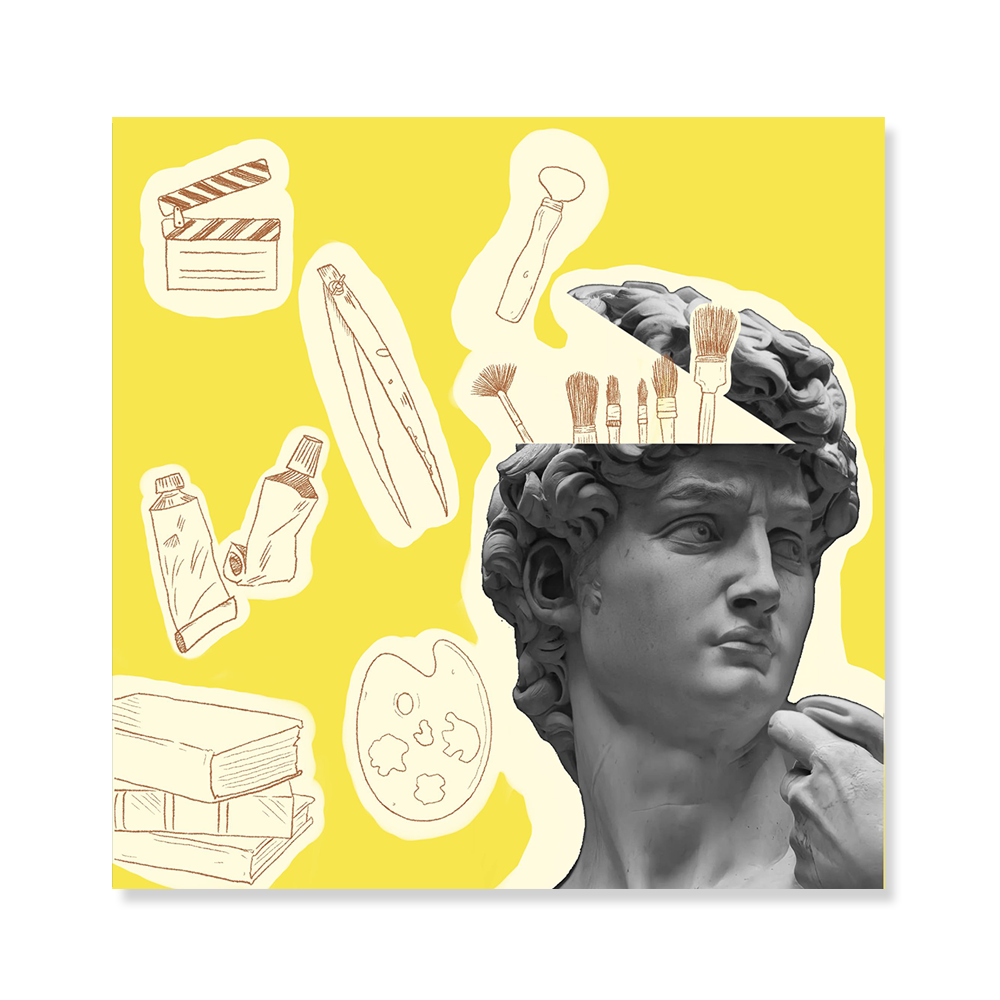
L’idea alla base dell’Abbecedario è stata quella di prendere spunto dai Sillabari di Goffredo Parise, un testo che sa cogliere l’essenziale attraverso la trasparenza delle parole. Tale approccio è ben illustrato dallo scrittore vicentino in questo articolo:
Un giorno, nella piazza sotto casa, su una panchina, vedo un bambino con un sillabario. Sbircio e leggo: «L’erba è verde». Mi parve una frase molto bella e poetica nella sua semplicità. Ma anche nella sua logica. C’era la vita in quell’erba è verde, l’essenzialità della vita e anche della poesia […]. Poiché vedevo intorno a me molti adulti ridotti a bambini, pensai che essi avevano scordato che l’erba è verde, che i sentimenti dell’uomo sono eterni e che le ideologie passano. Gli uomini d’oggi, secondo me, hanno più bisogno di sentimenti che di ideologie. Ecco la ragione intima del Sillabario.[1]
Parise scrive queste parole all’inizio degli anni Settanta, in un momento di crisi creativa dalla quale esce proprio grazie a questo piccolo evento, a questa epifania. L’opera che ne scaturisce – ovvero il primo volume dei Sillabari, pubblicato nel 1972[2] – segna una svolta in cui l’autore sembra quasi “reimparare” a scrivere, riuscendo a unire lo stupore infantile di chi guarda le cose per la prima volta alla lucida consapevolezza dello scrittore maturo. Il risultato è un testo unico nel suo genere: sperimentale eppure accessibile; semplice nella forma, ma complesso nella sua visione esistenziale.
È da questo schema che abbiamo preso spunto, pur consapevoli dell’irraggiungibilità del modello parisiano, per la realizzazione dell’Abbecedario del Made in Italy. Il primo passo è stato la scelta delle parole e dello stesso alfabeto: abbiamo optato per quello italiano piuttosto che per quello inglese. Allo stesso modo, abbiamo evitato i forestierismi, introducendo però due espressioni latine: humanitas e genius loci. Non lo abbiamo fatto per venerazione del passato o dei confini nazionali; al contrario, ad animare l’Abbecedario è una tensione costante verso l’apertura e il cambiamento, ma quelli veri, non quelli che ricorrono a termini alla moda – quasi sempre inglesi – per ammantare di novità idee stantie o nascondere un vuoto di senso.
Così, abbiamo cercato parole vive e non usurate. Il linguaggio, infatti, è soggetto a usura come e più degli oggetti. Pensiamo al termine “resilienza”, che non compare nell’Abbecedario. Fino a una decina d’anni fa, era quasi raro, circoscritto ad ambiti specialistici: usarlo al di fuori di quegli ambiti, in modo metaforico, era indice di ricercatezza, di studio, di una certa attenzione alla scelta delle parole. Tutto questo aveva un impatto su chi ascoltava, lo interessava, lo incuriosiva, forse perfino lo arricchiva. Oggi, invece, quella parola è entrata così prepotentemente nell’uso, che ne facciamo un continuo abuso, snaturandola, logorandola e privandola dell’originaria forza comunicativa: “resilienza” è ormai un termine che ci sentiamo quasi in obbligo di usare, ma che scivola via, non resta impresso nella mente del nostro interlocutore.
È per questo che, ad esempio, per dire “innovazione”, abbiamo scelto parole come “avanguardia”, “brevetto”, “progetto”, “talento”: parole semplici, d’uso comune, ma non usurate, perché portatrici di sfumature e di significati ancora da esplorare.
In alcuni casi, abbiamo cercato termini inaspettati. Ci è piaciuto molto “fatica”, una parola dura, vera, che però non ricorre spesso nelle narrazioni sul Made in Italy, dove invece si prediligono espressioni che emanino luce, positività: come se la realtà del lavoro quotidiano fosse un letto di rose.
Altre parole, infine, possono risultare non immediate: per essere comprese appieno, richiedono quei venti-trenta secondi di lettura della descrizione. In cambio, però, tentano di offrire uno sguardo diverso su concetti noti. Una di queste è “sinestesia”. Concedetele quei pochi secondi di lettura e vedrete come quella idea di esperienza sensoriale integrata e quella capacità di parlare simultaneamente a più di uno dei nostri sensi riassumano e distillino bene l’essenza di tanti prodotti del Made in Italy, e forse della nostra stessa identità.
Dopo avere scelto le ventuno parole, abbiamo scritto cinque racconti per quelle che iniziano con vocali e sedici descrizioni per quelle che iniziano con consonanti. Queste descrizioni, a loro volta, sono bipartite. La prima parte racconta un aneddoto – quasi sempre reale – che proviene dal mondo delle arti, della scienza, del costume… e che funge da approccio di ampio respiro al termine di riferimento. La seconda parte, invece, cala quel termine nel vivo del lavoro e dell’esperienza, in modo da creare tra le due sezioni una dialettica Spirito/Materia che ci è sembrato cogliere bene il carattere distintivo del mondo artigiano.
È la stessa dialettica che si ritrova nei racconti. In questi, abbiamo provato a seguire più da vicino la lezione di Parise, senza tentare di emularla. In particolare, ci siamo rifatti alla poetica del frammento: testi molto brevi, tra loro indipendenti ma che vanno a formare un mosaico comune. Sul piano stilistico, frasi brevi, semplici, orientate alla musicalità della resa orale. Un impianto realistico, con descrizioni marcatamente sensoriali, in cui avviene però un’epifania, un attimo di rivelazione in cui i personaggi o il lettore scoprono qualcosa che getta una luce nuova sull’intera vicenda.
Questi racconti sono costruiti su quattro cardini fondamentali del Made in Italy.[3] Così, Avanguardia si riferisce all’Innovazione; Ecologia alla Sostenibilità; Impresa e Orizzonte sono due parti di una stessa narrazione, associabili rispettivamente alla Cultura d’impresa e all’Internazionalizzazione. L’ultimo, invece, Ubiquità, non rispecchia uno dei suddetti cardini, ma rappresenta un concetto che, secondo noi, sintetizza tanti argomenti trattati nell’Abbecedario e costituisce una cifra dei tempi di cui tutti facciamo quotidianamente esperienza quando, per esempio, partecipiamo a una videochiamata e quindi ci troviamo ad abitare contemporaneamente il mondo reale e quello virtuale: quest’ultimo, come sappiamo, diventerà sempre più sfaccettato e preponderante, con l’evoluzione continua della tecnologia. Ma c’è anche un’altra accezione di ubiquità, ovvero quella del dover essere più persone allo stesso tempo, di dover ricoprire una molteplicità di ruoli e trovarsi a essere, come diceva Pirandello, Uno, nessuno e centomila.
Nel racconto finale, inoltre, si chiama in causa una parola che non compare esplicitamente nell’Abbecedario, ma lo attraversa in modo carsico dall’inizio alla fine: “autenticità”.
E non l’autenticità che richiama il carattere unico dei prodotti Made in Italy che in tanti cercano di imitare. Per quanto questo tema sia significativo, il centro focale della riflessione è forse un altro: l’autenticità contrapposta allo spettacolo. In un momento storico in cui tutto è spettacolo, tutto va spettacolarizzato per poter essere percepito e perfino per esistere, vista la molteplicità degli stimoli e il progressivo abbassarsi della soglia di attenzione, che spazio resta all’autenticità? L’autenticità di un gesto, di un mestiere, di una vocazione, quel quid che ti spinge a fare il tuo lavoro e a farlo a regola d’arte, anche quando la ragione ti dice che non ne vale la pena. L’autenticità, dunque, è anche conflitto interiore, dubbio, una domanda che ti scava dentro, una domanda continua, scomoda, perturbante.
Come dicevo, “autenticità” non rientra nel novero dei termini scelti e forse, come spesso accade, la parola più importante è proprio quella non detta.
© 2025 Spirito Artigiano. Tutti i diritti riservati.
[1] Goffredo Parise, «Il Gazzettino», 31 ottobre 1972.
[2] Il secondo volume è stato pubblicato nel 1982. Nel 1984, i due testi si sono fusi in un volume unico: Goffredo Parise, Sillabari, Milano, Mondadori, 1984.
[3] I quattro cardini (Innovazione, Sostenibilità, Cultura d’impresa e Internazionalizzazione) sono stati individuati da Confartigianato come assi portanti dell’artigianato italiano contemporaneo e presentati da alti esperti di ognuno di essi, durante l’evento del 15 aprile 2025 in cui l’Abbecedario è stato presentato in anteprima nazionale.
Beniamino Mirisola
Il Quaderno della Fondazione Germozzi, L’Abbecedario del Made in Italy – i nuovi linguaggi dell’Artigianato, undicesimo della collana curata dalla Fondazione, è frutto del lavoro sinergico di un gruppo interdisciplinare di esperti di Strategy Innovation. Realizzato con il contributo di professionisti provenienti da ambiti diversi, il progetto offre una visione innovativa dell’artigianato italiano contemporaneo. Beniamino Mirisola (autore di questo ‘pezzo’ su Spirito Artigiano Magazine), Martina Martinelli, Veronica Tabaglio, Chiara Fassetta e Gian Paolo Lazzer, ciascuno con competenze specifiche in identità culturale, intelligenza artificiale, sostenibilità e foresight strategico, contribuiscono alla definizione di un nuovo linguaggio per l’artigianato, in grado di coniugare tradizione e innovazione.

