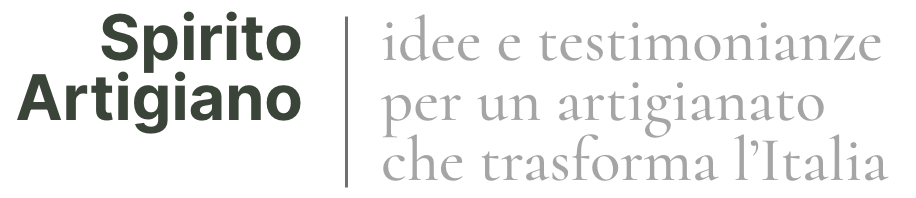A fine ottobre scorso, nel talk “La voce in mezz’ora”, è intervenuta la prof.ssa Raffaella Sadun, docente di gestione aziendale alla Harvard Business School, su un tema così titolato: Piccolo è davvero bello?.Il sito Lavoce.info spiegava che si era scelto di trattare “una peculiarità italiana: il nanismo d’impresa”. Secondo il sito, questa sarebbe “una caratteristica storica che oggi pone limiti alla crescita, alla produttività e alla capacità di innovazione del Paese”. Poi la domanda: “quale ruolo possono avere le politiche pubbliche e i cambiamenti organizzativi nel favorire lo sviluppo di imprese più solide e competitive?”
La prima impressione è che il titolo sia stato un po’ buttato là dagli organizzatori: si cavalca uno slogan che non circola più neanche negli ambiti della rappresentanza delle piccole imprese da almeno vent’anni.
In ogni caso la prof.ssa Sadun comincia il discorso già ben oltre quando cominciò ad affermarsi il mito. Infatti Piccolo è bello è il titolo del libro di Schumacher del 1973, scritto contro il gigantismo (cosa lì per lì neanche percepita al nostro interno; ci accorgiamo di chi siamo quando gli altri parlano di noi).
L’inizio dell’intervento della Sadun è comunque un po’ tranchant: afferma, per esempio, che “il fatto che le imprese più grandi siano più produttive e paghino di più” (!) viene messo in secondo piano dalle piccole, che farebbero un discorso culturale, cioè la butterebbero sulla narrazione a loro favore perché, si lascia intendere, dietro c’è poco.
La Sadun esordisce dicendo con sicurezza che produttività e salari non crescono perché l’Italia ha una moltitudine di “impresine” nane, che per loro natura – sostiene – non possono certo essere produttive. Se solo queste piccole raddoppiassero la dimensione, immediatamente – afferma – raddoppierebbero produttività e ricchezza del Paese (sic!). Quindi, secondo la docente, non si crescerebbe a causa dei piccoli: essi non possono permettersi investimenti negli intangibles, in R&S, marketing, digitalizzazione, valorizzazione delle persone, ecc., come invece sarebbe richiesto dal sistema industriale.
Dalla metà dell’intervista le risposte si fanno più articolate e sofisticate, perché non si parla più di “quale” impresa, ma delle azioni manageriali da sviluppare: per esempio nelle imprese familiari scindere la proprietà = soldi, dalla gestione = competenze.
Dispiace, fra l’altro, che mentre il management di un’impresa viene chiamato management, gli organici e le persone vengano chiamati “forza lavoro”, come stessimo parlando di un cavallo da tiro o di una forgiatura di metalli nell’antro di Sigfrido all’alba del capitalismo. Quindi il lavoro sarebbe un residuo della manodopera, mentre se si dicesse che anche un manager lavora sarebbe quasi offensivo: “ma per chi mi ha preso? Lavorerà lei, io dirigo!”.
Sarebbe troppo facile rispondere al punto interrogativo della frase “piccolo è davvero bello”, che comunque – come abbiamo detto all’inizio – è un’affermazione finita in soffitta da tempo fra gli addetti ai lavori e anche nella letteratura manageriale.
Per carità, le dimensioni nei fenomeni – e un’impresa è un fatto fenomenologico – esistono. Ma la loro descrizione è qualcosa che si modifica in continuazione, comprese quelle spaziali di “grande” e “piccolo”. La questione è l’adeguatezza dei lessici per cogliere la complessità. O forse, più semplicemente, per esplorarla, poiché – come diceva il compianto Richard Normann in Ridisegnare l’impresa. Quando la mappa cambia il paesaggio – quest’ultimo “sarà” il concept e lo strategic intent che ha, perché tutto il resto non lo decide lei. O meglio, per rispondere alla Sadun: può contribuire a deciderlo se si dota di una mappa in cui rinomina il paesaggio in cui opera, e rinominandolo lo cambia e lo rigenera. E questo potrebbe essere un concetto del “fare” proprio delle piccole imprese, quella “coscienza di luogo” su cui si spese molto un grande, Giacomo Becattini.
Comunque è intanto evidente che se ci sono tante imprese “nane” ci sono anche tanti consulenti che non riescono a uscire dagli stereotipi con cui da sempre si agghindano. Salvo poi doversi ricredere.
Aveva ragione il grande Henry Mintzberg, che a chi gli chiese una volta quale fosse per lui una definizione di “esperto” rispose: “nella mia lunga carriera mi sono imbattuto in diverse definizioni di esperto… ebbene, quella che preferisco è la seguente: l’esperto è colui che evita tutti i trabocchetti e marcia diritto verso il grande errore”. Cioè, alla fine: boom!, arriva il botto micidiale.
Aggiunse: “casomai non si fosse capito come stanno le cose: … mentre agli ultimi piani le Alte Direzioni, in ovattati uffici fra moquette e quadri d’autore, vanno proclamando ‘La qualità è il nostro primo obiettivo’, giù in basso i direttori di stabilimento vanno in giro cercando di salvare il salvabile”.
© Spirito Artigiano 2025. Tutti i diritti riservati.
Antonio Payar
Pratese, da studi classici e umanistici è passato poi ad approfondire temi manageriali verso la valorizzazione delle relazioni nelle organizzazioni. Ha ricoperto varî ruoli dirigenziali nel 'sistema Confartigianato'. Da sempre impegnato su tematiche sociali, culturali e politiche, è stato esperto del Cnel per l'immigrazione. Con il patronato INAPA di Confartigianato ha contribuito al Progetto nazionale per il 'Nuovo Sociale'. Collabora con la Direzione nazionale di Confartigianato e del Patronato per progetti speciali riguardanti il sociale/welfare e rapporti con altre istituzioni fra cui la CEI