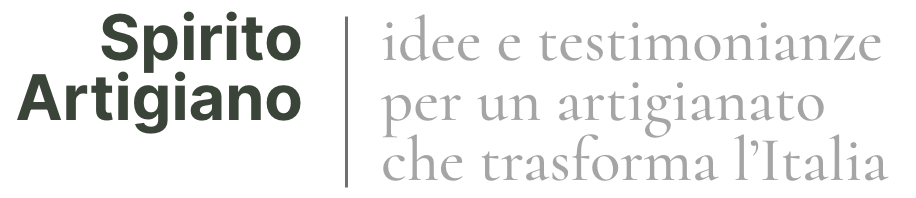Il concetto di cambio di paradigma è una espressione mutuata dal linguaggio di Thomas Kuhn, usata per descrivere il mutamento dirompente che avviene quando una scoperta scientifica rivoluziona tutta la conoscenza che si dava per assodata fino a quel momento. Riprendere questo concetto e riportarlo al centro del dibattito, non in termini scientifici, ma sociali, economici e politici, mi sembra essenziale perché un cambio di paradigma è esattamente ciò che stiamo vivendo. Senza riflettere su questo aspetto e sulla gravità e profondità del mutamento in corso, penso sia difficile poter riflettere sul futuro della nostra società e sulle risposte da cercare, che siano adeguate e all’altezza.
Il termine “paradigma” ha una forza espressiva molto radicale. Deriva dal greco e indica qualcosa di esemplare, a cui fare riferimento per comprendere l’orizzonte in cui si vive. Il paradigma è dunque ciò su cui si costruisce un modello sociale, filosofico, economico, politico. È il punto da cui si formano le identità e da cui le cose prendono forma.
Quindi, pensare che viviamo un cambio di paradigma significa immaginare di vivere in un momento di svolta totale della storia, un momento in cui tutto cambia.
Ma cosa succede quando un’epoca finisce e una nuova non inizia? Prendendo a prestito da M. Heidegger un’espressione, in questo momento noi ci troviamo su un sentiero che si perde nella complessa e intricata selva della contemporaneità. È questo il tempo in cui ci troviamo a vivere: un tempo che ci interroga e ci chiama, a cui dobbiamo dare una risposta per provare a dare vita, a generare, un nuovo fondamento, un nuovo paradigma all’interno del quale tornare a riconoscerci e che sia in grado di dare un senso alle nostre azioni.
Come tutti sanno, il 2008 ha segnato un momento di definitiva rottura: un’implosione del sistema che ha portato tutti, anche i più convinti assertori del neoliberismo, a interrogarsi su cosa si potesse fare per uscire dalla crisi e immaginare un futuro che, fino a quel momento, sembrava destinato a una sorta di perenne crescita, destinata a garantire a tutto il mondo, attraverso un sistema fondato su crescenti consumi e debiti, una situazione di perenne pace e prosperità globale.
Questo schema da sogno aveva comunque mostrato i suoi primi scricchiolii a partire dall’11 settembre 2001, una svolta dalla quale, in un certo senso, non siamo mai usciti. L’11 settembre ha spostato i nostri occhi da un orizzonte in cui pensavamo che tutto il mondo facesse a gara per assomigliare all’Occidente, per essere esattamente come noi. Invece ci siamo ritrovati a fare i conti con una violenza a cui non eravamo più abituati. E, quando ci siamo voltati per cercare nella nostra sacca delle risposte qualcosa con cui fronteggiare questa situazione, l’abbiamo trovata vuota.
La grande crisi globale in cui ci troviamo immersi è il portato di lungo periodo di queste due rotture. La domanda sull’identità è tornata molto attuale. Ed è una domanda potentissima: come ci pensiamo? Chi crediamo di essere? Chi siamo?
Quella dell’identità è una questione fondamentale. Un uomo che perde la memoria di sé, ovvero di chi è, non può fare altro che vagabondare, senza sapere dove andare. Finisce appunto su sentieri che si perdono nella selva. Ma cosa succede quando è anche il mondo attorno a noi a cambiare e quindi non abbiamo più strumenti da pescare nel passato per preparare la strada verso il futuro? Questa è la situazione in cui ci troviamo.
Non è del tutto vero che non avremmo strumenti da prendere dal passato per pensare il futuro, ma è vero che negli ultimi decenni l’idea di un modello economico che predicava espansione infinita ci ha fatto credere che l’unico orizzonte possibile di riconoscimento, di identità, di possibilità d’esistenza fosse al suo interno. E in questo ha avuto gioco facile, perché le altre cornici di senso e riconoscimento sono progressivamente venute a mancare, fino quasi a scomparire.
La religione perlopiù sbiadisce e si polarizza. Da un lato il fondamentalismo laicista ha avuto la meglio; dall’altro, il fondamentalismo religioso, come reazione a una società da cui ci si sente esclusi e in cui non ci si riconosce, tende ad avanzare. Ma senza un orizzonte metafisico in cui proiettare l’eccedenza di energia, di potenza, che risiede in ciascuno di noi, come si può avere un’esistenza formata, capace di dispiegarsi e di rinnovarsi? Tacitare la dimensione spirituale significa reprimere una parte fondamentale della persona e della sua capacità di aprirsi al mondo.
Allo stesso modo, la politica perde sempre più la capacità di svolgere il proprio ruolo storico, ovvero amministrare il potere facendosi portatrice di una visione concreta e possibile del futuro di una comunità. In un mondo sempre più interconnesso, in cui i centri di decisione sono sempre più diffusi e spesso non coincidono affatto con i governi, in cui le decisioni si accavallano e si influenzano reciprocamente con una velocità sempre più vorticosa, il ruolo della politica diventa meno chiaro; in balìa di chi promette di mettere un freno alla velocità del mondo, di chi pensa di potersi riparare dietro pareti di carta mentre fuori imperversa l’uragano.
La natura rifiuta il vuoto, dice un antico detto. E allora, il vuoto lasciato da queste due cornici di riferimento che per secoli hanno accompagnato lo sviluppo dell’uomo è stato occupato dalla tecnoscienza e da una parossistica forma di individualismo; perché in un mondo svuotato di senso e prospettiva – ovvero Dio e comunità – resta soltanto l’individuo con il suo solitario egoismo. E poiché l’economia è veramente la traduzione materiale dell’evoluzione culturale della società, individualismo radicale e tecnoscienza hanno trovato nel neoliberismo la dottrina che li univa e un modello da imporre, che definisco finanziario-consumerista. “Finanziario”, per la centralità del processo di finanziarizzazione, cioè degli effetti della deregolamentazione e della ingegnerizzazione finanziaria che hanno reso possibile la massiccia estensione delle possibilità di accesso al credito e dunque all’indebitamento. “Consumerista”, per la centralità del consumo come base del benessere e dell’identità, oltre che della crescita economica. Precisamente il modello che ormai da diversi anni è in crisi.
Da questa crisi emerge allora la necessità di creare un nuovo tipo di modello, che sia allo stesso tempo sociale, economico e politico: un nuovo scambio sociale che definisco sostenibile-contributivo.
Gli scambi sociali sono uno dei modi con cui si possono analizzare gli assetti socioeconomici avanzati, perché esistono scambi tra interessi economici, interessi sociali e interessi politici. Con il cambiamento epocale che stiamo vivendo dobbiamo interrogarci sulla storia da cui proveniamo e sul nuovo orizzonte in cui vorremo andare a collocarci.
Tra la fine della Seconda guerra mondiale e i primi anni ’70, il mondo occidentale è stato dominato da quello scambio che in letteratura si definisce fordista-welfarista, ovvero economie di scala ed efficientizzazione della produzione, rese possibili da mercati interni in espansione. Questo è stato ottenuto permettendo a quote crescenti di popolazione di accedere al circuito del consumo mediante salari stabili e tendenzialmente in crescita. Lo Stato estraeva risorse attraverso le tasse, redistribuiva in termini di servizi di welfare e creava consenso.
Questo modello è crollato già tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta.
© 2024 Spirito Artigiano. Tutti i diritti riservati.
Mauro Magatti
Laureato in Discipline Economiche e Sociali all'Università Bocconi di Milano e Ph.D. in Social Sciences a Canterbury, è professore ordinario all’Università Cattolica di Milano. Sociologo, economista ed editorialista del Corriere della Sera, membro della Commissione Centrale di Beneficienza della Fondazione Cariplo, del Comitato per la Solidarietà e lo sviluppo di Banca Prossima e del Comitato Permanente della Fondazione Ambrosianeum. Dal 2008 è direttore del Centro ARC (Anthropology of Religion and Cultural Change)