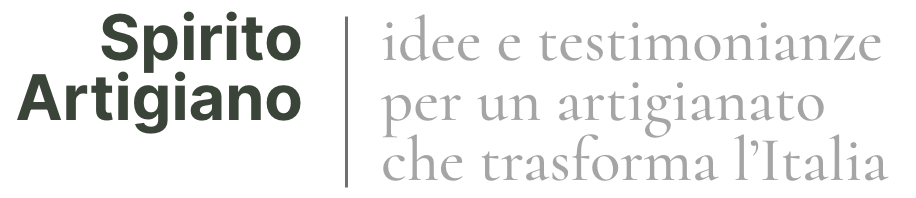Igles Corelli è ancora uno di quelli chef che preferisce essere chiamato cuoco. Anzi, lo dice lui stesso: «Io faccio il cuoco». Lo scandisce in dialetto stretto. Quella lingua a metà tra il romagnolo e il ferrarese tipica della terra di confine che gli ha dato i natali e da cui è partita la sua celebrità. Argenta. Il Trigabolo. Basta il nome per tuffarsi nella storia della ristorazione di cui Corelli è stato un protagonista indiscusso.
Per restituire la dimensione planetaria del suo talento, forse, basta ricordare che nel corso della sua sfavillante carriera è stato insignito di ben cinque stelle dalla guida Michelin. Volto da anni del Gambero Rosso, lo chef ha accettato di parlare con Spirito Artigiano di uno dei temi che gli sta molto a cuore: il rapporto tra il mestiere del cuoco e l’artigianato.
Chef Corelli, iniziamo da qui: quanto è rimasto di artigianato nel mestiere del cuoco che, forse, è quello che mediaticamente ha avuto più risalto negli ultimi anni?
“Fortunatamente resiste almeno un 50% di artigianato nel mestiere del cuoco. Benché a mio modo di vedere dovrebbe essere del tutto ancorato al settore artigiano. Non siamo industria. Noi lavoriamo con la creatività, le mani, la testa. Sono tutti elementi tipici dell’artigianato. Ma soprattutto, cerchiamo di mantenere il contatto con il produttore che – per alcuni ingredienti, io penso alle zucche – ha una cura particolare, quasi sartoriale”.
Quanto c’è di reale negli show televisivi rispetto al mestiere dello chef per come lo conosce lei?
“Dipende dalla trasmissione e dal programma. Ce ne sono tante che raccontano, anche con taglio più storico, la vita di alcune realtà ristorative che sono aderenti alla realtà. Ce ne sono altre, invece, che non raccontano la realtà e che sono invece solamente degli show. In questo momento storico stiamo vivendo un costante allontanamento delle persone dalle cucine”.
E questo secondo lei è figlio della falsa narrazione che si dà del mestiere?
“In parte sì. Il ruolo dei media, universalmente intesi, è fondamentale. E se da un lato può essere stimolante e avvicinare le persone ai “fornelli” dall’altro può essere distruttivo. In particolare per le giovani generazioni”.
È un lavoro per giovani?
“Lo è assolutamente. Il cuoco italiano è un ambasciatore del Made in Italy e, con questo expertise può girare il mondo portando con se la grande tradizione della cucina italiana. Il posto di lavoro, certamente, non gli mancherà. E le condizioni di vita massacranti sono una delle tante distorsioni cucite attorno a questo mestiere. Certo, occorre sacrificio, ma come in tutte le cose. È inconcepibile ai miei occhi che ci siano giovani a casa e ristoratori che cercano manodopera senza trovarla. Va invertito questo trend”.
Come è cambiata negli anni la percezione dello chef agli occhi dell’opinione pubblica?
“Al di là dell’opinione pubblica, è proprio cambiato il ruolo e il modo di approcciare al lavoro. Basti pensare che, solo quindi anni fa, la cucina era un tabù. Nessuno poteva accedervi, era un limite invalicabile. Oggi, invece, le cucine sono aperte e – spesso – a vista. Lo chef oggi è una star, viene chiamato come testimonial per campagne promozionali o informative. Per questo alcuni, anche, perdono la testa. L’importante è sempre mantenere il contatto con la realtà”.
La pandemia ha apportato qualche cambiamento anche ai fornelli?
“Diciamo che dopo il Covid abbiamo assistito a un ‘ritorno’ alla valorizzazione dei piccoli produttori. Si sta un po’ recuperando quel rapporto che prima mancava. Si stanno consolidando piccole realtà – e qui torna il tema dell’artigianato – che servono pochi clienti ma in maniera specifica, su prodotti ad hoc. Ora, va recuperato e rafforzato il rapporto tra piccoli produttori e ristoratori. Ma sono fiducioso”.
© 2024 Spirito Artigiano. Tutti i diritti riservati.
Federico Di Bisceglie
Dopo gli studi classici approda alla redazione de il Resto del Carlino di Ferrara, appena diciottenne. Nel giornale locale, inizialmente, si occupa di quasi tutti i settori eccetto lo sport, salvo poi specializzarsi nella politica e nell’economia. Nel frattempo, collabora con altre realtà giornalistiche anche di portata nazionale: l’Avanti, l’Intraprendente e L’Opinione. Dal 2018 collabora con la rivista di politica, geopolitica ed economica, formiche.net. Collaborazione che tutt’ora porta avanti. Collabora con la Confartigianato Ferrara in qualità di responsabile della comunicazione.