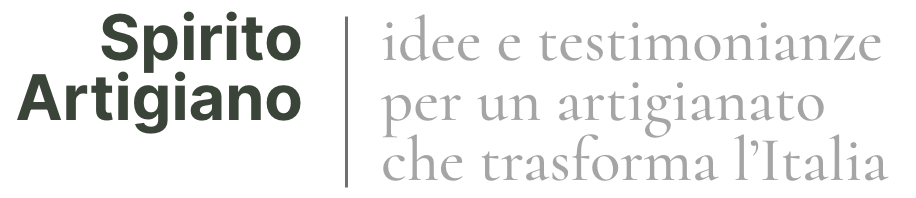Le “rivolte dei trattori” del 2024 hanno rivelato quanto sia complicato ragionare di transizione sostenibile nell’agroalimentare, un settore responsabile di quasi un terzo –dal campo alla tavola– delle emissioni climalteranti. In una lettera alla rivista *Nature*, un gruppo di ricercatori ha inquadrato il problema: «Mai nella storia si è registrata tanta pressione sugli agricoltori. Hanno la responsabilità di nutrire una popolazione mondiale in continua crescita e ora vogliamo anche che ci salvino dalle crisi del clima e della [perdita di] biodiversità, mentre le forze di mercato rendono la loro situazione finanziaria sempre più difficile». Complice l’incidenza della politica agricola comune sul bilancio europeo, il dibattito si è concentrato su quanto avviene nei campi e negli allevamenti.
La strada verso la transizione, tuttavia, non può prescindere da quanto avviene a valle: è nella produzione e nel consumo che l’artigianato potrà interpretare un ruolo chiave nel ripensamento dei sistemi del cibo
Alcuni numeri e aneddoti permettono di inquadrare un problema complesso. Il nostro modo di alimentarci, secondo la FAO, ha generato a livello mondiale quasi 13 trilioni di dollari di “costi nascosti” nel 2020. Di questi, il 20% è costituito dagli impatti sull’ambiente, il 75% se ne va in salute persa e nella conseguente mancata produttività. Ciò che rimane va attribuito a povertà e insicurezza alimentare. Nel 2021, secondo i dati Eurostat, ogni cittadino europeo ha sprecato 131 kg di cibo. Sterminiamo branzini e tonni per alimentarci, ma il mare ci può sostenere con oltre 2500 specie: pesci, certo, ma anche alghe e piante. L’ossessione per le proprietà benefiche dell’avocado ha scatenato gli italiani. Quarantacinque milioni di kg di drupa verde consumano sei volte il loro peso in carburante in tre settimane di viaggio per riempire le cucine nelle pokerie italiane. Tre settimane e una lavorazione che diluiscono i drammatici costi ambientali, idrici e sociali delle coltivazioni in Sud America.
Anche se si riempie la bocca di frasi fatte e formule vacue prelevate dal dibattito mediatico o social sul “food and wine”, il consumatore medio ha perso il legame con il cibo, la sua produzione, le sue implicazioni. Le fix tecnologiche –siano le app di liquidazione dell’invenduto o la carne coltivata per sostenere i consumi di proteine senza sacrificare animali– sono importanti ma non alzano il velo, anzi lo infittiscono.
Dissolta nelle catene lunghe e nelle “black box” dell’industria alimentare, la consapevolezza sul cibo è diminuita. Se si ritroverà, sarà per gli effetti di un nuovo patto tra produzione e ristorazione artigianali e consumo. Il patto che intravedo si dispiegherà, se sarà, su scala urbana e regionale.
Tratteggio la proposta.
Il valore dell’artigianato nella produzione e nella ristorazione sta in tre elementi: il possesso di certificate, sicure e radicate competenze tecniche; l’essere al centro di fitti reticoli sociali, dalle filiere di fornitori ai distributori; l’aver capacità e scala necessaria per sperimentare e innovare con agilità
Ognuno di noi può rapidamente richiamare alla memoria qualche “prototipo” di artigiano sperimentatore e promotore di pratiche sostenibili. In fin dei conti si tratta di specialisti del gusto e delle tecniche capaci di scomporre e ricomporre i cibi “della tradizione” su una matrice tipica innestata di nuovi elementi. Si tratti di cuochi in grado di costruire menu che valorizzano l’interezza del pescato, compreso il quinto quarto, o di artigiani del vino e “garagistes” che in vigna o in cantina esplorano approcci e tecniche nuovi per valorizzare il territorio e rispettarlo, abbondano nel tessuto artigianale italiano. A loro si presenta l’opportunità di essere catalizzatori della transizione capaci di mobilitare intorno alle loro sperimentazioni le filiere locali, il consumo e la sua cultura. Le città-regione sarebbero il perimetro delle filiere e delle culture da ricombinare e da cui creare ponti con altre geografie e culture con la sostenibilità in testa. Dovranno unire alla sperimentazione una parallela operazione di racconto: dare conto, nell’incontro con il consumo, delle geografie delle materie prime, delle loro specificità, delle interazioni tra produzione, ambiente, lavoro qui e nel mondo.
Un reprise del chilometro zero e delle filiere cortissime? No. Piuttosto una missione nuova: restituire a chi mangia gli strumenti concettuali necessari per far ridisegnare con le proprie scelte i sistemi del food e le logiche con cui verrà apprezzato –e pagato– il loro lavoro. Non si tratta di un blocco di artigiani, agricoltori e consumatori compatto contro il nuovo e quanto viene da fuori. Piuttosto una presa di consapevolezza del senso del limite: quanto e quando l’avocado diventa una *liability* offensiva per il pianeta? Quanto e come è possibile rivolgersi all’industria del cibo dopo che si è imparato a guardare nuovamente ai processi che per molto tempo sono stati sottratti alla visibilità?
Certo, ad oggi e in assenza di adeguati supporti, la sostenibilità rischia di essere una minaccia per gli artigiani del cibo e della cucina a fronte di un consumo diseducato, di una distribuzione fortissima e di industrie dei prodotti finiti o di materie prime capaci di vincolare molto chi prepara e produce i nostri alimenti
Due le soluzioni per vincere i timori dell’artigianato verso questa rinnovata funzione. La prima è una politica capace di facilitare questo ruolo di raccordo tra innovazione, culture sedimentate e salde del cibo e sostenibilità nel mondo artigianale, recependone le istanze e dispiegando, dalla formazione tecnica e professionale alle misure di incentivo economico, tutto l’armamentario disponibile. La seconda, protagoniste le associazioni di categoria, le fondazioni e le associazioni di artigiani, è quella di riconoscersi, fare massa per rappresentarsi efficacemente come motori della transizione, formarsi vicendevolmente e farsi formare per rinnovare di continuo l’insieme di strumenti e approcci utilizzati per interpretare questo ruolo. Iniziative come la statunitense *James Beard Foundation*, che organizza workshop per preparare gli chef a diventare i motori della riconfigurazione sostenibile delle filiere del cibo, è uno dei tanti modelli a cui ispirarsi.
© 2024 Spirito Artigiano. Tutti i diritti riservati.
Vladi Finotto
Vladi Finotto, Ph.D., è Professore Associato di Management all'Università Ca' Foscari di Venezia dal 2008. Specializzato in Imprenditorialità e Strategia, le sue ricerche si concentrano sulla riconfigurazione dei modelli di business e sull'innovazione strategica, con particolare attenzione all'industria alimentare. Autore di pubblicazioni internazionali e coordinatore di progetti di ricerca di rilievo, è anche delegato per il trasferimento tecnologico e l'imprenditorialità, promuovendo collaborazioni tra università e industria per lo sviluppo economico