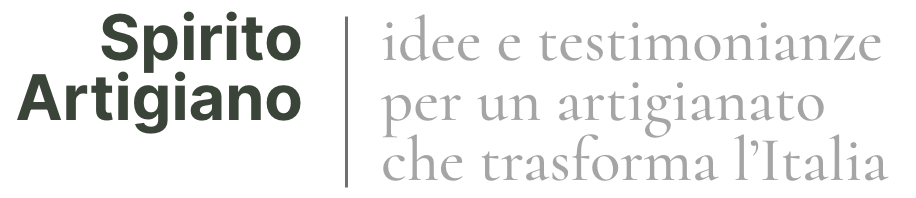La ribalta che in queste settimane ha finalmente assunto la forte criticità in cui versa il comparto dell’automotive ridà la giusta importanza a un settore corposo e centrale nella vita della manifattura italiana ed europea.
L’industria delle industrie: è così che nel tempo è stato giustamente definito il settore dell’auto, vera e propria colonna vertebrale di una robusta manifattura, proprio nella consapevolezza del forte contributo che lo stesso fornisce all’occupazione, alla crescita economica e allo sviluppo industriale di un Paese.
Occuparsene bene oggi è l’unica vera chance per ridare gambe e fiato a una questione insieme antica e tanto moderna: fare politica industriale.
Il settore dell’automotive non vive una ciclica e pesante crisi congiunturale come le altre. È il settore industriale maggiormente messo alle corde dal concentrarsi di più cambiamenti strutturali e nuovi: transizione ecologica, innovazione tecnologica, confronto/scontro tra economie continentali, modifiche negli stili di acquisto e di mobilità tra i consumatori, fusione tra case produttrici costituiscono un mix di cause potenti e al tempo stesso molto critiche che stanno disorientando in tutta Europa manager industriali, governi, sindacati, opinione pubblica.
La transizione ecologica è certamente oggi la questione più additata e dibattuta, con cui fare i conti. L’Unione Europea, nel segno del Green Deal, ha varato norme con obiettivi ambiziosi di transizione, a partire dalla cessazione della produzione di auto con motori a scoppio dal prossimo 2035. In tanti ora chiedono, spaventati dalla situazione, di rivedere o abolire questo programma.
Il sindacato dei metalmeccanici, Fim-Cisl in testa, ha invece sempre detto 3 cose semplici, finora inascoltate: non ci interessa posticipare di pochi anni tale scadenza, sarebbe un prendere tempo poco utile; l’UE deve aprirsi invece al concetto di “neutralità tecnologica”, ovvero spingere verso soluzioni tecniche diverse dal “puro elettrico” che permettano la riduzione delle emissioni; ma soprattutto l’UE deve dotarsi di un piano di sostegno agli investimenti e all’occupazione all’altezza della posta in gioco, cosa che non ha colpevolmente finora fatto. Produrre un’auto elettrica impiega mediamente il 20% di manodopera in meno rispetto a un’auto tradizionale. Sarebbe folle non mettere in campo risposte e interventi. Le scadenze UE, più che abolite, vanno accompagnate in modo robusto.
Va inoltre evidenziato che la transizione verso l’elettrico è stata avviata proprio mentre la domanda di auto ha subito in tutta Europa un calo molto significativo.
Rispetto agli anni pre-Covid, non solo in Italia ma in tutta Europa, si vendono molte meno auto. Gli esperti sostengono che questa stagnazione continuerà. Gestire la transizione con un mercato in calo triplica le complicazioni per chi fa industria. Il calo della domanda è legato a più fattori: certamente il rialzo dei prezzi legati all’inflazione, l’incertezza su cosa sia meglio acquistare che fa rinviare scelte di acquisto, ma anche la minore propensione dei giovani ad acquisire la patente e a possedere un’auto costituiscono cambiamenti epocali.
In Italia il valore medio di una nuova auto acquistata è passato in pochi anni da 18mila euro a 26mila. E non è un caso che ben 2/3 delle auto oggi comprate sul mercato siano usate. Ma non è solo un problema di reddito, è anche un cambiamento negli stili di vita e nella propensione a investire soldi in un bene materiale.
Inoltre, per molte case automobilistiche, tedesche in testa, i mercati cinesi e asiatici sono stati negli ultimi 10 anni importanti mercati di sbocco in espansione. Oggi non è più così, soprattutto perché i costruttori asiatici hanno imparato a produrre auto affidabili, belle e a basso costo, con le quali sono pronti a invadere l’Europa (segnatevi, se non lo conoscete ancora, il marchio cinese BYD, che sta già penetrando fortemente i mercati nordeuropei).
Questa inversione di tendenza acuisce i problemi in Italia sulla filiera della componentistica, forse il principale valore aggiunto del settore automotive italiano, vista la stagnazione della produzione di Stellantis. La componentistica italiana si è da tempo specializzata sul “powertrain”, ovvero sulle parti legate al motore a scoppio, e in stretto supporto all’industria tedesca ora travolta da una squassante crisi: due fattori importanti che la mettono alle corde.
Solo in questo quadro è possibile poi collocare la situazione di Stellantis, che non va invece vista, come oggi tutti declamano sui media, come una crisi di sola incapacità manageriale. Cominciamo col dirci che se FCA fosse rimasta fuori dal gioco pur duro delle alleanze e fusioni (che portano sempre a sovrapposizioni), sarebbe stata destinata a un ancora più critico declino. Stellantis nasce quasi 4 anni fa come quarto gruppo mondiale, mettendo insieme oltre 14 marchi storici. Non è bastato dire che nessun marchio veniva soppresso o che nessuna fabbrica sarebbe stata chiusa. Stellantis non è finora riuscita ad andare al di là della propria nascita. Ha una vera e propria crisi di modelli vincenti, lo dimostrano le quote di mercato in riduzione in un mercato già depresso.
Stellantis sta soffrendo, forse più di altri costruttori, le incertezze del mercato e della svolta verso l’elettrico, ancora troppo condizionata dalle politiche altalenanti dei governi in termini di incentivi e di rete disponibile (le famose colonnine da diffondere sulla rete stradale). Gli ingenti investimenti sulle nuove piattaforme e modelli non stanno marciando verso risultati produttivi apprezzabili.
Dentro questa difficoltà globale, Stellantis ha un problema con il nostro Paese. Sono mancati, a governo e sindacati, interlocutori di riferimento continuativi e autorevoli sulle strategie industriali.
La recentissima nomina di Jean Philippe Imparato a responsabile anche per l’Italia può essere la risposta. Ma ora serve che il gruppo ridefinisca e garantisca un piano industriale che potenzi la collocazione di nuovi modelli vincenti nei diversi siti, risponda alle realtà più in difficoltà come Mirafiori, confermi l’investimento a Termoli nella gigafactory e si impegni con i sindacati a una gestione trasparente, di sviluppo e coerente.
Al governo tocca ridare gambe a come fare politica industriale in questo Paese. Dopo aver inseguito per 12 mesi patti evanescenti, ora è il momento delle risposte. Riassegnare le necessarie risorse al fondo pluriennale per l’automotive scippate dalla manovra di bilancio è fondamentale. Ma poi occorre saperle tradurre in reale sostegno agli investimenti per la transizione.
Il sindacato ha sempre sostenuto che, oltre a occuparsi di difesa dell’occupazione, il governo deve aiutare le imprese a trasformarsi. Un produttore di marmitte, componente che non esiste più in un’auto elettrica, deve essere sostenuto nel cambiare produzioni.
Il sindacato dei metalmeccanici sta combattendo in questi anni una strenua battaglia per la tenuta del settore e per evitare bagni di sangue occupazionali. Lo ha fatto non solo con gli scioperi, ma definendo ormai 3 anni fa un innovativo documento di proposte congiunto con Federmeccanica (gli industriali) che indicava cosa fare. Documento totalmente inascoltato da chi governava allora e oggi.
Il tema decisivo per cui il sindacato si batte è come rendere socialmente sostenibile questa transizione. Servono non solo ammortizzatori adatti, ma piani per rinnovare l’occupazione e aggiornare le competenze. Ne va anche della qualità della democrazia nel nostro Paese. Se gli operai che producono le auto non possono più comprarle perché troppo care (cosa invece accaduta per interi decenni e che oggi diventa impossibile per un’auto elettrica), si rischia di buttare ulteriore benzina verso un populismo dannoso e corrosivo per la società.
L’automotive costituisce oggi il principale banco di prova per dare gambe a un’indispensabile politica industriale, senza la quale il settore uscirà a brandelli dalla transizione. Non si tratta solo di mettere in campo soldi pubblici. La politica industriale si fa anche con impegni di tutti i protagonisti, industrie in testa, finalizzati a scelte industriali coraggiose e costruttive, condivise tra le parti e organizzate nel tempo.
L’automotive è anche uno dei principali terreni dove l’Europa potrà fare passi in avanti (curvando il Green Deal in modo più pragmatico, affrontando la concorrenza asiatica non solo con i dazi, varando misure di accompagnamento che rendano la transizione socialmente sostenibile e percepita come tale), o rapidi passi indietro lasciando ogni governo ad affrontare da solo la propria situazione industriale.
L’Italia, con meno industria e automotive, non potrà che stare peggio. Non dimentichiamoci, infine, che sostenere ogni posto di lavoro nell’automotive significa occuparsi di lavori meglio pagati e più sicuri della media. Significa quindi sostenere dove il lavoro può e potrà avere più valore, dando maggiore sostanza alla crescita e al tipo di sviluppo che vogliamo nel Paese.
© 2024 Spirito Artigiano. Tutti i diritti riservati.
© Foto di Anastasiya Badun da Pexels
Roberto Benaglia
E' un sindacalista italiano con una lunga esperienza nel settore delle relazioni industriali e della tutela dei lavoratori. È stato Segretario Generale della FIM CISL dal 2020 al 2023, guidando l'organizzazione in un periodo di grandi trasformazioni per l'industria e il mercato del lavoro, con un focus su innovazione, transizione digitale ed economia sostenibile.
La sua carriera sindacale si è sviluppata principalmente all'interno della CISL, dove ha ricoperto diversi ruoli di responsabilità, tra cui la direzione delle politiche contrattuali e della formazione.
Durante il suo mandato alla guida della FIM CISL, ha promosso il dialogo sociale, la contrattazione inclusiva e la formazione continua per i lavoratori, contribuendo a modernizzare il sindacato e rafforzarne il ruolo nelle sfide del XXI secolo.
Attualmente si dedica a progetti di ricerca e consulenza nel campo delle politiche industriali e del lavoro.