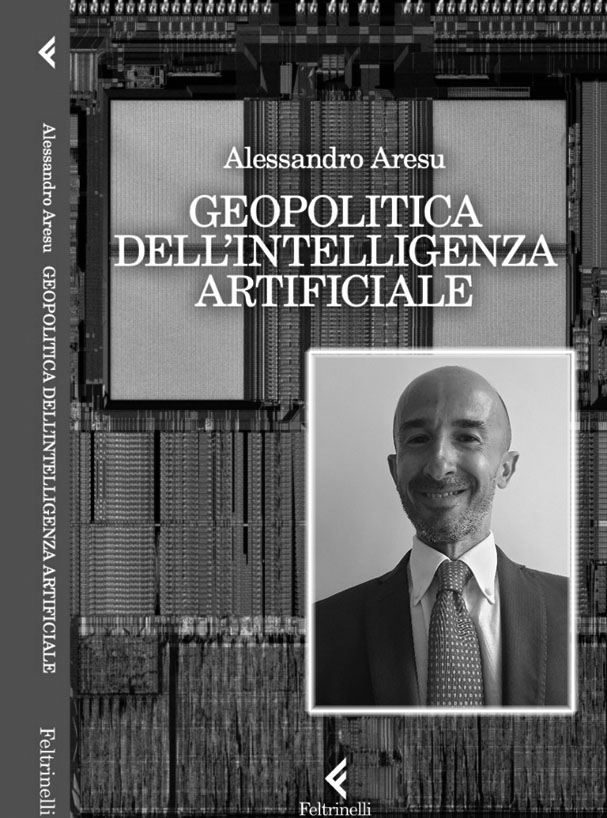
Alessandro Aresu (autore di vari libri sugli scenari globali, consigliere scientifico di Limes, già consigliere e consulente per 12 anni di istituzioni tra cui la Presidenza del Consiglio, il Ministero dell’Economia, il Ministero degli Esteri, l’Agenzia Spaziale Italiana), nel suo ultimo libro – Geopolitica dell’intelligenza artificiale – sottolinea che a fronte delle necessità di sviluppare le nuove frontiere dell’AI, occorrono dei maxi data center con un dispendio elevatissimo di energia e con un forte impatto sull’ambiente.
Non le sembra una grandissima contraddizione dei tempi moderni?
«Credo sia il caso di evitare un’ipocrisia fin troppo diffusa, e quindi anzitutto dobbiamo avere una consapevolezza degli elementi industriali ed energetici che caratterizzano la nostra vita digitale, studiando le imprese e le filiere coinvolte, come propongo nei libri e nei saggi che ho scritto negli ultimi dieci anni e a cui rimando per ulteriori approfondimenti. Per la produzione di uno smartphone, o di altri oggetti su cui basiamo le nostre vite, esistono ovviamente sempre costi energetici e ambientali, oltre a organizzazioni di filiere con diverse competenze. Per avere consapevolezza di cosa sia l’intelligenza artificiale, dobbiamo quindi conoscere le sue fabbriche (i data center e come funzionano, quali aspetti li caratterizzano, quali materiali, quali sistemi di interconnessione) e le “fabbriche delle fabbriche” che sono i vari segmenti dell’ecosistema dei semiconduttori, nel cammino della digitalizzazione del mondo che va avanti dagli anni ’40 e ha reso possibile tutto ciò che oggi, nella vita professionale e personale, diamo ormai per scontato.
Niente di tutto questo, compresi i data center, è stato “inventato” dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale, e questo deve esserci chiaro per fare un discorso informato. Da un lato, il contenuto elettronico principale dei data center dell’intelligenza artificiale nasce, come ricordo nel libro “Geopolitica dell’intelligenza artificiale”, per far fronte a un tema che tecnicamente riguarda la fine della Dennard scaling, e quindi proprio la corrispondenza tra riduzione del consumo energetico e aumento delle prestazioni. Ora, siccome data center teoricamente meno impattanti a livello energetico sono però sempre più ampi e con prestazioni molto migliori, è chiaro che in alcune comunità possono esserci fenomeni di sovraccarico energetico e idrico (basti pensare al consumo energetico in un luogo dove c’è concentrazione in Europa, l’Irlanda). Dipende ovviamente anche dal mix energetico dei vari Paesi. Il mondo, comunque, non sarà ricoperto di data center, questo processo non potrà aumentare all’infinito coi tassi di crescita che abbiamo visto negli ultimi anni.»
È possibile, dunque, secondo lei registrare un passo avanti in termini di innovazione, senza avere un eccessivo impatto sull’ecosistema?
«Direi con franchezza di no: questa è la risposta onesta da dare. Ogni soluzione industriale ha un impatto sull’ecosistema e continuerà ad averlo, poiché l’intelligenza artificiale è una filiera industriale e un ecosistema “puro”, senza l’intervento umano, non può esistere e non esiste in nessun luogo, soprattutto in un’epoca di sviluppo industriale e dove miliardi di persone vogliono legittimamente entrare nel benessere. Per questo è così importante conoscere in modo approfondito le filiere industriali di cui parlo nei miei libri.
A partire dal riconoscimento di questa realtà, non dobbiamo però raccontarci che esista una sorta di “destino progressista” dell’intelligenza artificiale dove tutto andrà bene per forza, dove tutto sarà in qualche modo “aggiustato” dall’intelligenza artificiale stessa, non si sa bene come. Invece, ci sono molti temi specifici da affrontare. Tanto per fare un esempio, l’economia dei data center ha un impatto occupazionale ridotto, come ricordo nel mio libro. Nei prossimi mesi e anni, dovremmo sempre più considerare anche altre implicazioni e “case” dell’intelligenza artificiale, dagli sviluppi delle biotecnologie alla robotica.»
Confartigianato ha lanciato una campagna dedicata alla valorizzazione dell’Intelligenza Artigiana. Quale la ricetta per far convivere le due “intelligenze” evitando di cadere nella contraddizione?
«È una domanda cruciale e che deve stimolare molte riflessioni.
A mio avviso, visto che i dati di alfabetizzazione digitale delle imprese e della pubblica amministrazione vedono il nostro Paese in una posizione arretrata ormai da anni, quella artigiana sarà sempre più una “intelligenza” del domani se saprà intervenire su questo divario digitale, su questo divario di competenze digitali, a partire dalla sua comunità di protagonisti. Colmare il divario digitale, nelle sue varie dimensioni, permette una migliore organizzazione del lavoro e dei processi, per dare spazio alla creatività e anche per cogliere nuove opportunità di mercato.
Allo stesso tempo, dobbiamo chiederci ciò che l’intelligenza artigiana ha da insegnarci ancora oggi. E si tratta di una domanda molto attuale. A mio avviso, nell’epoca degli strumenti che ora chiamiamo di “intelligenza artificiale”, ma più in generale nell’evoluzione del digitale in questo secolo (penso ai social media), vediamo chiaramente una trasformazione dell’attenzione e delle dinamiche di apprendimento. In questo frangente, il rischio è perdere confidenza con la pratica, l’esercizio, l’attenzione che è una parte essenziale dell’intelligenza artigiana, e dovremmo considerare essenziale per la formazione in generale, così come lo è la lettura attenta di un lungo romanzo, l’immersione nella sua storia, rispetto alla lettura di un riassunto fatto più o meno bene. L’intelligenza artigiana, a partire dalla sua pratica, può avere il ruolo di ricordarci in modo costante, in quest’epoca, che il valore aggiunto nelle decisioni e nei processi viene anche da questi tempi lunghi, di cui secondo me abbiamo bisogno per dare profondità alla nostra umanità.»
Che ruolo pensa possa avere l’Italia nello sviluppo dell’AI?
«È normale che l’Italia non abbia una leadership nell’intelligenza artificiale perché i maggiori produttori di talento al mondo sono Cina e India, e il maggiore magnete del talento coincide ancora con gli Stati Uniti. Inoltre, l’Italia ha una ridotta capacità finanziaria, oltre a vincoli stringenti di bilancio, e non ha grandi imprese digitali. Pertanto, è inutile fare in Italia e in Europa discorsi sulla “leadership” in questo campo o sulle regole che dovremmo imporre agli altri: si tratta di una perdita di tempo, un discorso che tra l’altro non interessa per niente al resto del mondo.
Il ruolo dell’Italia può quindi riguardare, in modo più concreto, quattro aspetti: uno, il sostegno alla ricerca fondamentale e alle competenze tecnico-scientifiche che sono essenziali per lo sviluppo e il governo di queste tecnologie; due, le politiche, anche salariali, per l’attrazione e il mantenimento dei talenti; tre, il presidio di alcune nicchie industriali dell’ampia filiera elettronica; quattro, l’adozione di soluzioni legate all’intelligenza artificiale per aumentare la competitività della manifattura, in particolare della meccanica.»
Ritiene possa essere impiegata l’AI nelle imprese artigiane, che rappresentano la stragrande maggioranza del nostro sistema economico, evitando una contraddizione?
«Come ho detto, non esiste una contraddizione bensì un divario di competenze digitali che si può colmare oppure no, e che è meglio colmare.
Per esempio, un artigiano, se lavora con una macchina, ha uno strumento che prima o poi dovrà effettuare una manutenzione. Prevedere i difetti della macchina, attraverso la sua connessione con un sistema di macchine e l’analisi dei dati, può essere sicuramente utile per quell’artigiano che può rimodulare il suo lavoro creativo rispetto al tempo che libera.»
© 2025 Spirito Artigiano. Tutti i diritti riservati.
Federico Di Bisceglie
Dopo gli studi classici approda alla redazione de il Resto del Carlino di Ferrara, appena diciottenne. Nel giornale locale, inizialmente, si occupa di quasi tutti i settori eccetto lo sport, salvo poi specializzarsi nella politica e nell’economia. Nel frattempo, collabora con altre realtà giornalistiche anche di portata nazionale: l’Avanti, l’Intraprendente e L’Opinione. Dal 2018 collabora con la rivista di politica, geopolitica ed economica, formiche.net. Collaborazione che tutt’ora porta avanti. Collabora con la Confartigianato Ferrara in qualità di responsabile della comunicazione.

