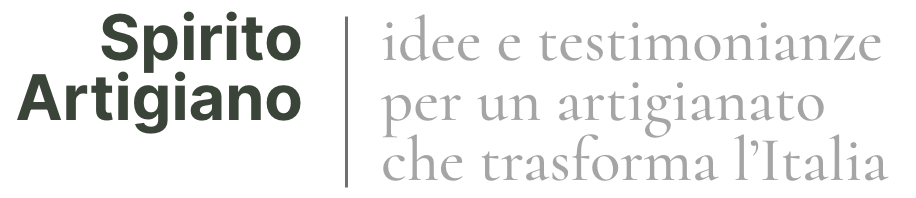I dati consolidati relativi al mercato del lavoro più aggiornati, riferiti al terzo trimestre del 2023, sono tutti eccezionalmente positivi. Gli occupati sono aumentati complessivamente del 2,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+481.000 unità): sono saliti a 23.613.000, stabilendo un record da quando possediamo serie storiche sulle forze di lavoro (il 1977). La creazione di occupazione è stata trainata dai rapporti di lavoro dipendente permanenti (a tempo indeterminato), che hanno registrato una variazione più che proporzionale rispetto all’incremento medio dell’occupazione, con una crescita su base annua pari a +3,1%. Al contrario, i dipendenti a termine sono diminuiti (-2,3%). E i lavoratori indipendenti (artigiani, commercianti, professionisti, imprenditori) sono aumentati dell’1,6%. Inoltre, abbiamo avuto più impieghi a tempo pieno (+2,7%) che part time (-0,7%). Sono diminuiti i disoccupati e gli inattivi, è salito il tasso di occupazione (anche il tasso di occupazione giovanile registra una differenza positiva pari a +0,8%). Pure le retribuzioni medie sono aumentate: +3,3%. E l’input di lavoro misurato in termini di ore lavorate attesta un incremento pari a +1,8%, superiore alla (debole) crescita del Pil (+0,1%). Tutto bene, dunque?
Siamo passati in tempi rapidissimi dalle preoccupazioni suscitate dalla precarietà del lavoro e dagli allarmi per gli elevati tassi di disoccupazione, specie giovanile, a un completo rovesciamento dello scenario
Adesso è il sistema produttivo a lamentare ogni giorno difficoltà nel reperire la manodopera e le figure professionali di cui ha bisogno.
La ripresa dell’occupazione nell’ultimo biennio è stata decisamente robusta. A causa della pandemia, tra i mesi di gennaio e luglio del 2020 avevamo accusato un crollo di lavoratori che ha sfiorato il milione di unità (-937.000 addetti). E abbiamo dovuto attendere il secondo semestre del 2022 per tornare ai livelli antecedenti all’emergenza sanitaria. Però dal luglio del 2020 al dicembre del 2023 (il dato più recente disponibile) i posti di lavoro sono aumentati complessivamente di oltre 1,6 milioni di unità.
Abbiamo quindi capito che il fenomeno delle «grandi dimissioni», che recentemente aveva occupato il proscenio nel discorso pubblico sul lavoro, era solo un abbaglio, se inteso come fuga dal lavoro tout court. È vero che negli ultimi anni le dimissioni volontarie (si parla di rapporti di lavoro, ovviamente, non di persone) sono aumentate da 1,2 milioni nel 2016 a 2,2 milioni nel 2022, con un incremento evidentemente molto consistente. Più in dettaglio, prima della pandemia, le dimissioni erano state 1.723.753 nel 2019; nel 2020, ovvero nella fase più acuta dell’emergenza sanitaria, si era verificata una flessione (-16,2%) dipendente dal congelamento del mercato del lavoro in quell’anno (si ricordi, ad esempio, il blocco dei licenziamenti per decreto) e dalla sospensione dei progetti individuali da parte di molti; la flessione era stata subito riassorbita nel momento in cui l’impatto della pandemia si era attenuato, con un nuovo balzo del 33,6% nel 2021 rispetto all’anno precedente; successivamente, nel 2022, le dimissioni volontarie sono state 2.200.026 (+13,9% in un anno). Poi, a partire dalla fine del 2022 e nel corso del 2023, non solo la crescita delle dimissioni si è arrestata, ma si registra al contrario una riduzione del fenomeno. Si tratta di una inversione di rotta correlata al contestuale incremento del numero di lavoratori dipendenti permanenti. Questi dati ci fanno capire che una gran parte delle dimissioni volontarie non era motivata da una presunta crisi esistenziale dal sapore vagamente new age, come era stato veicolato mediaticamente con l’espressione «great resignation». Era riferibile, invece, alle decisioni prese da persone, prevalentemente giovani, che interrompevano i rapporti di lavoro prima della scadenza alla ricerca di opportunità lavorative più gratificanti sul piano della retribuzione, dell’orario di lavoro o delle mansioni.
Insomma, siamo passati, come si è visto, dalle «grandi dimissioni» al boom di occupati. A questo punto, sgombrato il campo dagli equivoci, è più utile parlare, semmai, di «quite quitting», per usare un’altra espressione americana: il rischio di disimpegnarsi dal lavoro
Quello che sta accadendo, in realtà, dipende innanzitutto dal fatto che hanno cominciato a scaricarsi sul mercato del lavoro gli effetti della radicale transizione demografica che il Paese sta vivendo, caratterizzata dal prolungato e intenso processo di denatalità, al punto che oggi le coorti di giovani stanno diventando una relativa rarità. Le proiezioni demografiche al 2050 ci dicono che l’Italia sconterà, fra meno di trent’anni, una riduzione di circa 7,8 milioni di persone in età attiva. Il sistema produttivo lo ha capito, e al momento è impegnato ad attrarre o a trattenere il capitale umano di cui necessita mediante offerte di lavoro più allettanti: è la legge del mercato, bellezza!
Paradossalmente, l’inferiorità numerica delle giovani generazioni si sta capovolgendo in un punto di forza: il peccato originale di essere pochi – si pensi alla ridotta capacità di rappresentare le proprie istanze generazionali e alla scarsa incidenza politica, in quanto nessun leader politico guarderebbe con interesse un bacino di potenziale consenso elettorale talmente esiguo e che si va ulteriormente restringendo nel tempo – si sta traducendo, di fatto, in un aumento del loro potere contrattuale nelle dinamiche di domanda e offerta di lavoro.
Se questo è vero, possiamo attenderci nel prossimo futuro una pressione al rialzo sulle retribuzioni, per la verità gravemente stagnanti in Italia negli ultimi trent’anni, avendo rappresentato un fattore di costo sottoposto a una forte compressione al fine di non compromettere i livelli di competitività del nostro sistema d’impresa. Un prevedibile rialzo del costo del lavoro potrà verosimilmente inficiare gli equilibri di bilancio di quelle imprese che finora erano riuscite a rimanere sulla linea di galleggiamento.
Se, come si è appena visto, la prima linea di frattura rispetto al mercato del lavoro tradizionale dipende dalle tendenze demografiche – a causa soprattutto dell’inversione della piramide demografica, negli ultimi dieci anni registriamo una riduzione di oltre 360.000 occupati con meno di 35 anni –, bisogna ammettere che si è aperta anche una seconda faglia, che riguarda la sfera motivazionale.
Specialmente tra i giovani, si sta consolidando un modo diverso di rapportarsi al lavoro, che si fonda sull’idea che il lavoro non rappresenti più il baricentro dell’esistenza. Nell’attuale ciclo storico-sociale rischia di compromettersi la funzione tradizionalmente assolta dal lavoro come strumento per accrescere la prosperità economica e migliorare il benessere sociale. Conseguentemente, il lavoro rischia un declassamento rispetto alla centralità avuta in passato – e fissata sin dall’articolo 1 della nostra Costituzione.
Nella ridefinizione della gerarchia delle proprie priorità, accanto al lavoro prendono sempre più spazio aspetti diversi della vita. A cominciare dal bilanciamento tra gli impegni lavorativi e gli affetti, il tempo libero, le passioni personali. Che si tratti della settimana lavorativa di quattro giorni o del ricorso sistematico allo smart working, le nuove richieste sono tutte tese a liberare tempo dal lavoro
Per comprendere meglio questa svolta, bisogna aggiungere la constatazione che oggi il lavoro non è più una formidabile leva identitaria. «Dimmi che lavoro fai e ti dirò chi sei»: una volta si poteva dire così – si pensi al Cipputi di Altan, con la tuta da metalmeccanico e la chiave inglese stretta in una mano: il suo lavoro definiva la sua stessa identità.
In definitiva, come si sarà capito, la chiave per decifrare i cambiamenti che stanno avvenendo nel rapporto degli italiani – e in particolare dei giovani – con il mondo del lavoro è il fattore tempo: risorsa per definizione preziosa ed esauribile. Secondo una duplice accezione. Il tempo inteso in senso dinamico: se vengono meno le aspettative riposte nel lavoro come mezzo preferenziale per migliorare la propria condizione futura, allora il lavoro perde la sua antica primazia. E il tempo inteso in senso statico: se viene meno la proiezione nel futuro, allora nel momento presente è preferibile sottrarre al lavoro quanto più tempo è possibile.
© 2024 Spirito Artigiano. Tutti i diritti riservati.
Foto di Kampus Production
Massimiliano Valerii
Massimiliano Valerii è direttore generale del Censis. Dopo gli studi in Filosofia a Roma, si è dedicato alla ricerca sociale, economica e territoriale. È il curatore dell’annuale Rapporto sulla situazione sociale del Paese, pubblicato dal 1967 e considerato uno dei più qualificati e completi strumenti di interpretazione della realtà socio-economica italiana. È autore di La notte di un’epoca (2019), Il contagio del desiderio (2020) e Le ciliegie di Hegel (2022), tutti pubblicati da Ponte alle Grazie.