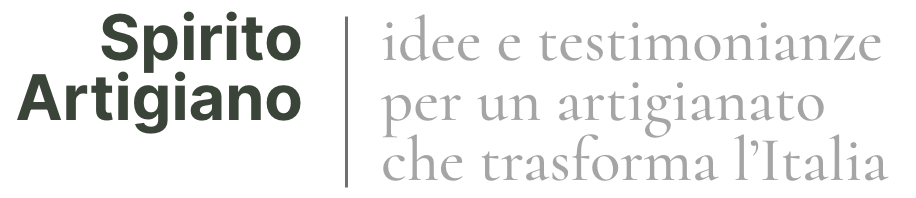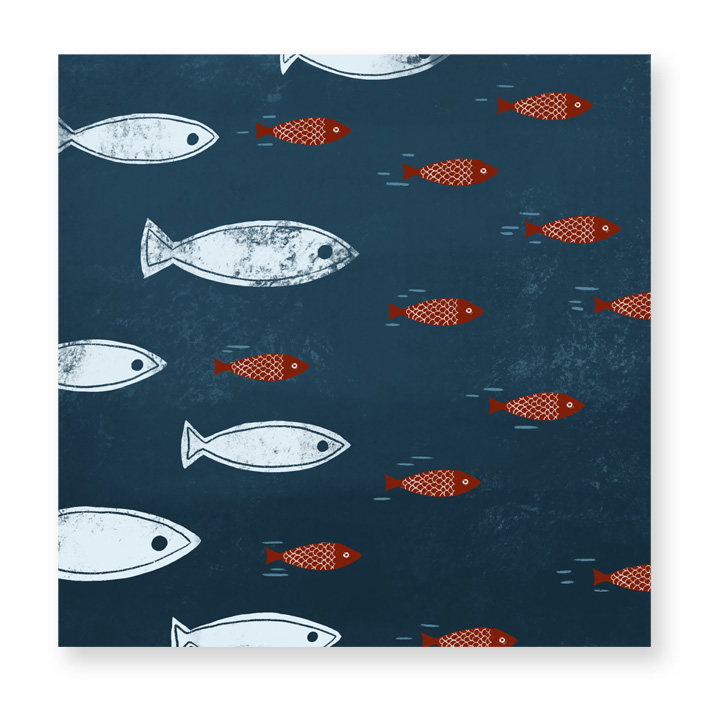
In un mondo che cambia velocemente, e procede verso nuovi assetti competitivi e sociali, non c’è niente di peggio del fatto di guardare il presente con gli occhi del passato, magari senza rendersene conto. Buona parte dei pregiudizi che ruotano intorno al concetto di dimensione di impresa nasce da questo atteggiamento, a metà tra il distratto e il nostalgico, perché dà per scontato che la grande o grandissima impresa sia la chiave per entrare nel futuro (globale, digitale, manageriale, illuminato e altro), assegnando a tutto il resto un ruolo residuale o perdente.
‘Nanismo di impresa’: un’anomalia da correggere?
Quante volte, ad ogni sintomo di crisi, abbiamo sentito dire che “piccolo non è più bello” e che il nanismo delle imprese italiane è un’anomalia da correggere, riconvertendo rapidamente il nostro sistema produttivo maggiori dimensioni di impresa, pena l’uscita dal mercato e dall’orizzonte del futuro. E quante volte, non appena la crisi allenta la sua stretta, si constata invece – con sorpresa, talvolta con disappunto – che le imprese italiane di piccola e media dimensione, nel loro insieme, hanno tenuto, reagendo prontamente alle situazioni in cambiamento. Tanto da realizzare performances simili e qualche volta superiori a quelle delle grandi imprese dello stesso settore. D’altra parte, i distretti industriali, in cui operano migliaia di piccole imprese specializzate nelle diverse funzioni della filiera, non sono affatto “morti”, come più volte annunciato. Al contrario, sono tutt’oggi vivi e vitali, grazie alla loro capacità di trasformarsi, adattando al nuovo le diverse ecologie produttive che ogni territorio ha ereditato dal proprio passato.
Dunque, per dare senso a quanto accade sotto i nostri occhi, è necessario mettere meglio a fuoco il ruolo che la dimensione, grande o piccola, può avere oggi nella transizione in corso.
Dal fordismo alle imprese a taglia variabile
L’idea che l’evoluzione del capitalismo sia inevitabilmente diretta verso un unico modello di efficienza e di competitività, basato sulla massima dimensione di impresa possibile, non è di oggi, ma risale agli anni del fordismo “vincente” (dal 1920 al 1970), quando la massima efficienza era effettivamente ancorata a soluzioni tipiche della grande impresa. Fondamentalmente in due modi: aumentando i volumi delle vendite di prodotti standard; e portando sotto il controllo diretto del management tutte le possibili funzioni della filiera, grazie all’integrazione verticale dell’intero ciclo produttivo, dalla materia prima al prodotto finito. Per mezzo secolo si è così andati avanti con processi di concentrazione dimensionale che hanno messo fuori gioco le imprese ereditate dall’epoca precedente, sostituendo artigiani e piccoli imprenditori con organizzazioni di grande scala, ancorate alla gestione manageriale e programmata delle linee produttive.
Ma questo modello, che ancora oggi tiene banco nella discussione pubblica sul futuro possibile, è entrato in crisi già nel corso degli anni settanta, quando le grandi imprese non si sono rivelate adatte a gestire, con la necessaria flessibilità la crescita della complessità che rendeva impossibile calcolare, programmare e gestire dall’alto situazioni sempre più fluide, e fuori programma. E’ su questa smagliatura che si è innestata la rapida crescita delle piccole e medie imprese dei distretti industriali italiani, man mano che i grandi produttori hanno affidato all’esterno quote crescenti delle funzioni produttive della filiera, avviando importanti processi di outsourcing e di downsizing. Lo stesso, in quegli anni, è avvenuto in Giappone (con le catene dei fornitori esterni che lavorano just in time con il cliente) e negli Stati Uniti (con la soluzione della cosiddetta extended enterprise, che supera i confini del controllo proprietario diretto). La transizione post-fordista è continuata, dopo il 2000 con l’avvento di Internet e il superamento conseguente della barriera della distanza, che ha allargato lo spazio della divisione del lavoro tra imprese a scala globale, coinvolgendo una grande varietà di fornitori, ricercatori, clienti, comunicatori dotati di capacità, tradizioni e convenienze assai diverse tra loro.
Imprese grandi e piccole in transizione
Dal 2000 in poi, sia le piccole che le grandi imprese sono così entrate in transizione, dovendo re-inventarsi rispetto ai modelli del passato. In questo processo, i grandi hanno sperimentato forme nuove di decentramento delle competenze e delle responsabilità, che de-verticalizzano le precedenti piramidi organizzative e aprono alle relazioni esterne a tutto campo, soprattutto con le piccole e medie imprese delle filiere in cui si opera. Ma anche i piccoli si sono trasformati, re-inventando il proprio modello di business. Non tutti, certo, ma sicuramente quelli maggiormente dotati di visione del futuro e di spirito imprenditoriale.
A questo fine, le piccole imprese possono fare leva su due elementi che caratterizzano la transizione attuale, valorizzando il ruolo dell’imprenditorialità in quanto tale, a prescindere dalla dimensione:
- a) la generazione del valore è oggi sempre di più affidata a filiere estese formate da una pluralità vasta e differenziata di imprese, nelle quali non conta tanto essere grandi, quanto sapere offrire un contributo utile e non sostituibile alla filiera di co-produzione del valore;
- b) prodotti e processi si vanno ri-personalizzando, perché le imprese devono gestire la sempre maggiore complessità (varietà, variabilità, interdipendenza, indeterminazione) del mondo digitalizzato. Per muoversi in un contesto del genere, l’uso di algoritmi e automatismi è indispensabile per abbattere i costi e accelerare i tempi, ma il fattore critico che serve per gestire le interazioni complesse tra chi offre e chi domanda è l’intelligenza delle persone.
Le piccole imprese, in un contesto del genere si qualificano non per la loro scala dimensionale, ma per la loro capacità di offrire contributi creativi alle filiere estese, di appartenenza, e per mettere in azione persone intraprendenti, in quanto imprenditori, dipendenti o fornitori che collaborano per il risultato
In questo modo, si apre uno spazio di competitività futura che può essere praticato con successo da piccole imprese intraprendenti che mettono in programma il superamenti dei limiti importanti che ancora oggi, in parte, le caratterizzano. Si tratta di avviare importanti processi di apprendimento sul terreno dei codici digitali (da imparare rapidamente), del capitale umano (da rinnovare), degli investimenti (da potenziare anche con alleanze e creazione di reti di impresa), della comunicazione (da associare alla creazione di significati condivisi e di “comunità di senso” con i potenziali clienti).
Essere piccoli, dunque, non è un vantaggio, ma nemmeno una sciagura che condanna ad un declino predestinato. Si tratta invece di fare leva sui vantaggi differenziali, sopra ricordati, per re-inventare i propri metodi di invenzione e di azione, riducendo al tempo stesso gli handicap importanti che continuano ad esistere, rispetto alla transizione in corso.
Non lo si può fare da soli, ma lavorando insieme con altri: le Associazioni imprenditoriali possono fare molto al riguardo.
Enzo Rullani
Senior Researcher dell’Università Ca’ Foscari e fellow della Venice International University, sul tema dell’economia della conoscenza in rete. Ha lavorato come docente e ricercatore presso le Università di Venezia Ca’ Foscari, Bocconi, San Raffaele, Verona, Udine. È stato visiting scholar presso il MIT di Boston.
Ha fatto parte dei comitati scientifici del Centro Studi Confindustria, della Fondazione Nordest, di Symbola e di diverse riviste, tra cui Economia e Politica Industriale, Communitas, Economia dei Servizi, Studi Organizzativi, Sinergie, Finanza, Marketing e Produzione, Sviluppo locale, Economia e Società Regionale, Sociologia del Lavoro. I suoi temi di studio attuali sono l’economia della conoscenza, la digital transformation, la nuova imprenditorialità, i problemi del lavoro nella transizione in corso, l’intersezione tra filiere globali e distretti locali.