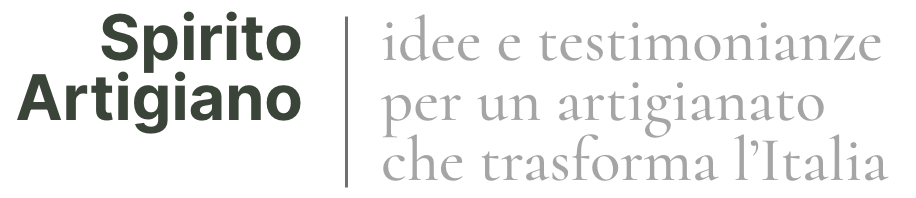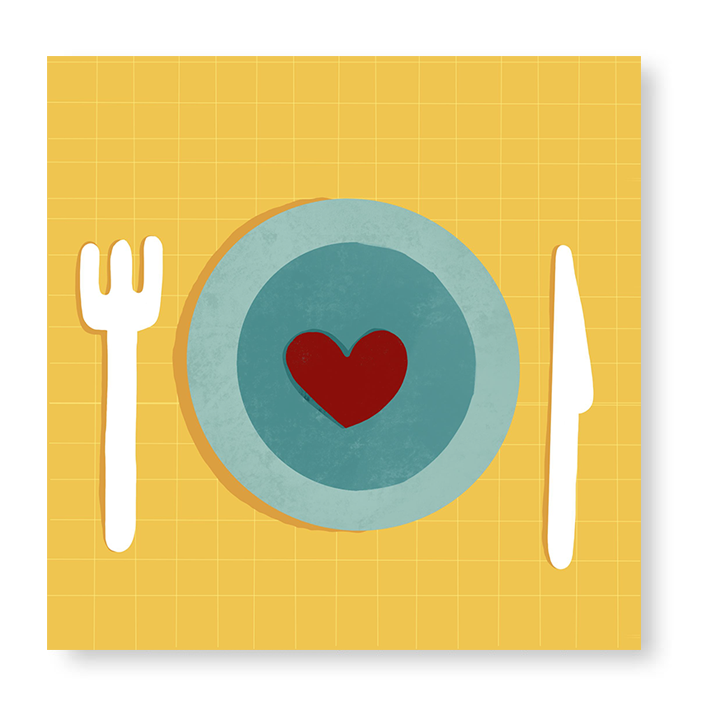
E’ stata la rivoluzione francese che ha creato la ristorazione moderna. Decapitati gli aristocratici, i loro famosi cuochi rimasero disoccupati e diedero allora vita a quel fantastico strumento della modernità che è il mangiare in pubblico usando una cucina per un certo tempo e per taluni cibi. Si creò in tal modo un circuito virtuoso tra mercato, alimentazione, costumi e modi di vivere. Nutrirsi con cura e scegliendo volta a volta con che cosa nutrirsi cessava di essere un privilegio di pochissimi e diveniva una possibilità per molti. In tal modo, nel XIX* secolo, tutto cambiò nell’ alimentazione sociale: dalla disposizione dei cibi sulle tavole al modo di vestire mentre si pranzava: le culture del mangiare mutarono profondamente. Solo la borghesia poteva far ciò, disponendo, sì, di denaro, ma non in misura così ampia come l’ aristocrazia, che poteva permettersi un cuoco tutto per sé. Ma anche la borghesia, allora, e, oggi, invece, tutta l’ umanità nei paesi affluenti, instaura con il mangiare in pubblico una ritualità complessa e stratificata: ci si veste in un certo modo se si va da McDonald e quel modo è assai diverso da quello che usiamo se si va da Simpson sullo Strand a Londra. Si mangiano in pubblico cibi che spesso non si mangiano nella propria casa, o per mancanza di materia prima o per incapacità nella preparazione. Il ristorante è un’invenzione possibile perché unisce la dimensione di scala che consente il magazzino di alimenti di cui una famiglia non può disporre con una tecnicalità professionale che fonda, appunto, la ristorazione moderna. Dall’ aristocrazia francese siamo giunti alla ristorazione di massa… Cibarsi, dunque, è un fatto sociale. Lo sappiamo e non abbiamo più dubbi: è una verità incontestabile. Cibarsi è un atto transitivo, una logica d’azione che mi pone in relazione con gli altri, una cultura in senso antropologico, ossia un attribuire significati alle cose e trasformarle in tal modo in simboli che riempiono di senso la nostra vita.
Quello che voglio dimostrare in questo mio breve contributo è che anche il cibo è un fatto culturale e sociale, ricco di significati
Quello che voglio dimostrare in questo mio breve contributo è che anche il cibo è un fatto culturale e sociale, ricco di significati.
Anzi, voglio dimostrare che ciò che ho nel mio piatto vive una vita che va oltre il suo manifestarsi nella forma fisica: il cibo ha una sua vita, il cibo è un simbolo che mi lega e mi collega a un evento, a un luogo, a una storia. E tanto più colui che si nutre di esso comprende tutto questo, tanto più soddisfa il desiderio che costituisce il nostro mondo vitale più forte e potente: quello del piacere sensuale che è tipico di una nutrizione colta e della consapevolezza dell’ essere nella storia anche attraverso il cibo.
Cibo da popoli: un altro brand. Discorrendo di pizza
Perché si può sostenere questa tesi? Perché il cibo è una filiera di eventi e di processi sociali, non è un fatto naturale, ma artificiale e storico. Il cibo inizia dalla materia prima naturale. Poi essa viene manipolata e costruita attraverso una lunga serie di pratiche che si sono accumulate nel tempo storico e che sono il frutto dell’invenzione. Dell’ invenzione o di popoli o di solitari produttori che dai popoli si distaccano: i cuochi aristocratici, per esempio, i cuochi che ho prima ricordato e che oggi sono ritornati agli onori del mondo con la nascita, circa trent’ anni or sono, della ristorazione di marca. Ossia la ristorazione da chef come brand: Bocuse e Marchesi ne sono gli archetipi essenziali. Volete un esempio, invece, della ristorazione e del cibo che nasce dal ventre dei popoli? Pensate alla pizza. L’Italia è famosa per la pizza. Essa nasce dalle viscere del popolo napoletano, quello cantato da innumerevoli poeti e sublimato da innumerevoli scrittori. È un cibo semplice che non spezza il legame della materia prima: il grano è la natura, nel nostro immaginario, ora e sempre, quali che siano, invece, le tecniche raffinatissime con cui lo si coltiva. Il grano: basta trasformarlo in farina e condirlo, durante la lievitazione e la cottura, con il pomodoro e con un alimento tra i più complessi che esista al mondo: la mozzarella. La pizza è, quindi, da un lato il prodotto del grano che cresce dietro le spalle di Napoli, a Sud, nel tavoliere delle Puglie e giunge nella città e assieme a esso giunge il pomodoro. Ma il pomodoro inizia a unirsi alla pizza solo dopo la scoperta dell’America, perché prima esso era sconosciuto in Europa. Ma la pizza “napoletana” si accompagna anche con un prodotto frutto di pratiche secolari di allevamento del bufalo mediterraneo e di lavorazione del suo latte: la mozzarella, appunto. La pizza è, dunque, il frutto di un passato agrario antichissimo che affonda le sue radici nella romanità. Ma è anche il frutto della scoperta dell’America e quindi di un evento che fonda la nostra modernità. Ma ecco che ritorna la tradizione, e che tradizione: una tradizione millenaria: quella dell’allevamento su larga scala di un tipo di ruminante che poteva vivere nelle pianure paludose che danno un tratto singolarissimo al Mezzogiorno d’Italia. La pizza è tutto ciò, tra modernità e tradizione. Ma per divenire tutto ciò occorreva che queste pratiche e queste culture si ricomponessero continuamente attraverso una specializzazione professionale: i pizzaioli. Essi sono una specializzazione professionale tipicamente urbana. Sono tra gli emblemi della città un tempo grande capitale e grande incunabolo di una cultura popolare immota e silente rispetto alla grande storia, ma sempre presente nella vita quotidiana del popolo.
La pizza è Napoli e lo è in tutto il mondo. Quando la mangio ricordo Napoli e il suo popolo ovunque io sia nel mondo
La pizza è Napoli e lo è in tutto il mondo. Quando la mangio ricordo Napoli e il suo popolo ovunque io sia nel mondo. Volete una prova di ciò? Pensate al fatto che una specie di pizza senza pomodoro e senza mozzarella, e che quindi non è più pizza… esiste in tutto il mondo. In Turchia ovunque e in ogni piatto, sulle Ande insieme alla manioca, in Cina quando mangiate l’anatra laccata, trovate degli alimenti costituiti da un foglio di pasta di grano più o meno sottile che riempirete di altri cibi e di altri ingredienti. Ogni volta che a diverse latitudini e longitudini voi farete questo capirete che quell’atto vi fa condividere nell’ alimentazione le culture storico-concrete dei popoli che quelle “pizze non napoletane” vi offrono… Ebbene, ogni volta voi incontrerete una materia prima, più materie prime, diversi modi di manipolarle e di renderle appetibili e diverse strategie di alimentazione a esse legate: tutto ciò corrisponde a diverse storie che quei popoli, cibandosi in quel modo, raccontano a se stessi e a gli altri.
In questo senso la “pizza napoletana” è anch’essa un brand, ma un brand impersonale e collettivo, che funziona nel sistema di significati come una sorta di archetipo junghiano: finiamo per appartenere noi a tale sistema di segni e di valori, ovunque ci troviamo nel mondo. Funziona in modo così perfetto, questo brand impersonale, da diventare il modello per brand molto meno ricchi di storia: pensate alla catena Starbuck e capirete cosa voglio dire: nei suoi locali non si vende caffè, ma un modo di riposarsi, di incontrarsi, di porsi in contatto con gli alimenti all’interno di una rete di servizi che fonda il brand e lo fa divenire un mito collettivo.
È la “pizza napoletana” che fonda il significato: se la consumo, consumo anche i racconti che sono in essa e che con essa io incontro quando mi accingo a cibarmene. Se lo so gusto ancor più la pizza ed entro nel giardino del desiderio appagato, che in tal modo diviene un mio arricchimento personale e migliora la mia vita. Tanto quella di relazione quanto quella interiore.
Il cibo ha una sua vita, insomma e ha un suo racconto. Occorre saperlo leggere. Se lo si sa fare si vive molto meglio.
Il brand famigliare. Discorrendo di amor di sé
Vi siete mai svegliati con nelle narici il profumo di un piatto che vostra nonna preparava quando eravate bambini e che ora vostra moglie o il vostro partner hanno imparato a cucinare e che, ogni anno, nel giorno del vostro compleanno vi si offre, come un regalo e come un atto d’amore? Penso di sì. Penso che un’esperienza simile sia successa a ciascuno di noi. Proust si svegliava al mattino ricordando la madeleine che sua madre gli offriva appena sveglio. Negli anni ne avrebbe fatto un simbolo personalissimo, l’emblema di un amore straordinario e fantastico. In ognuno di noi vive un’esperienza proustiana, quale che sia la nazione, la città, il paese in cui siamo nati e in cui siamo cresciuti. E quel cibo, quel piatto, diviene un elemento della nostra storia familiare, un archetipo di una giovinezza e di una educazione così come lo sono un libro prediletto o un’amicizia che non ci abbandona più sin dall’infanzia. Per me questo cibo prediletto è costituito dalle cotolette di coniglio che la mia nonna paterna mi preparava il giorno del mio compleanno in campagna, in un piccolo paese del Monferrato, dove si coltiva da sempre il vitigno della barbera e dove i grandi vini si sposano con il gusto per la cacciagione e per l’allevamento degli animali domestici, tra cui il coniglio. Mia nonna lo preparava in un modo antichissimo, quasi arcaico. Lo uccideva lei stessa, con grande naturalezza. Lo appendeva appena ucciso a un palo appositamente costruito e ne tagliava la gola per raccoglierne il sangue, che impastava con la mollica di pane. Di quell’impasto avrebbe fatto un flan che cuoceva a bagno maria nell’angolo del camino, divenendo un antipasto con i fiocchi. Il coniglio veniva poi disossato in parte e ridotto in due tipi di preparazioni alimentari. Da un lato lo si cuoceva in umido con il vino barbera, dopo averlo fatto marinare per una intera notte. Dall’altro lato lo si consumava subito in forma di cotoletta impanata con l’uovo e con il pane grattugiato: cotolettine caldissime, buonissime che si divoravano in un battibaleno e che diffondevano per la casa un profumo meraviglioso, che si mescolava con quello del vino in cui marinava il coniglio rimasto, che si sarebbe mangiato il giorno dopo. Si mescolavano in quelle preparazioni riti antichissimi. Riti sacrificali pre-crisitani, quando si offrivano agli dei gli animali sgozzati raccogliendone il sangue. Riti di purificazione con la lavanda delle carni e delle pelli. E, infine, riti moderni come quello dell’amalgama dell’uovo e del pane per mangiare le carni: un’abitudine da società affluente e ricca, che lambiva anche l’universo contadino e che si preparava, appunto nei giorni di festa. Questo piatto, questa preparazione del coniglio, è un elemento importante della mia storia personale. Non so vivere senza di essa: mi ricorda l’infanzia e un periodo felicissimo della mia vita, passato nelle campagne del Piemonte in modo spensierato e sublime.
Anche questo, quindi, è il cibo e la nutrizione: un momento del nostro autoriconoscerci e del nostro amor di sé.
Mi auguro che tutti voi ne abbiate uno, di questi piatti famigliari che migliorano la nostra vita. La migliorano perché possiamo raccontarci con gioia, ricordando i nostri cari, i nostri affetti.
Bibliografia essenziale
C.Lévi-Strauss, L’ origine delle buone maniere a tavola, Il saggiatore, Milano, 1971
J.Goody,Food and Love. ACultural History of East and West, Verso, New York-London, 1998
C.M.Counihan,The Antropology of Food and Body.Gender, Meaning and Power, Routldlege, London-New York, 1999
E.N.Anderson, Everyone Eats: Understanding Food and Culture, New York University Press, New York, 2005
Giulio Sapelli
Giulio Sapelli, già Professore ordinario all’Università degli Studi di Milano ed editorialista, unisce economia, storia, filosofia, sociologia e cultura umanista in una sintesi originale e profonda. Ha insegnato in Europa e nelle Università delle due Americhe, in Australia e Nuova Zelanda. I suoi lavori sono stati tradotti in tutto il mondo.
E’ Presidente della Fondazione Germozzi ed è impegnato a valorizzare il concetto di Valore artigiano, che è forza di popolo, di persone e di imprese legate da uno spirito unico, il quale esprime la vocazione originaria incline alla creatività e all’amore per la bellezza.