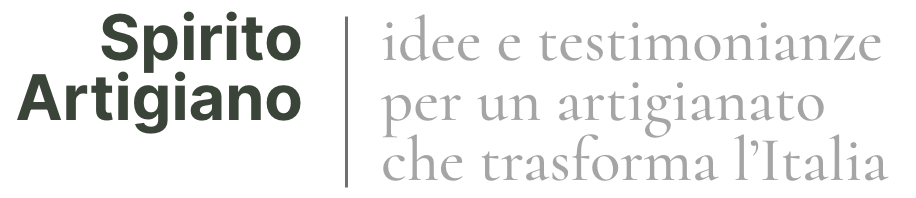Per alcuni giorni all’inizio di questo novembre ho passato circa una settimana al Cairo e ad Assuan, invitato dall’Università Statale Gāmaʿat al-Qāhira, a svolgere un breve ciclo di lezioni sulla storia recente dell’economia mondiale (dalla crisi del 2007 a oggi). È stata una occasione unica che mi ha molto impegnato e reso felice come può esserlo uno scienziato sociale dinanzi all’oggetto cangiante della sua vita: il terribile mondo umano in trasformazione.
È stata un’eccezionale occasione di vivere da vicino – a poche centinaia di chilometri di distanza – un dramma storico che si consuma sotto gli occhi di tutto il mondo. Io potevo viverlo non attraverso le lenti deformanti delle televisioni internazionali, come ho cercato di raccontare criticamente con il mio settimanale articolo (che pubblico ormai da anni) su Il Sussidiario.net. Vivere al Cairo, proprio in quel distretto storico di Giza dove l’università è stata fondata ai tempi dei monarchi riformatori nel 1908. Nel tempo del governo britannico e del khedivè Abbās Ḥilmī, forte della recente lotta contro il Mahdi, la prima violenta rivolta integralista del finalismo islamico, e della conquista del Sudan. Per diversi giorni abbiamo vissuto, noi non egiziani ancor più dei colleghi cairoti, una situazione che pareva sospesa tra il dramma prossimo e la quotidianità che ci circondava. E ogni giorno, per spostarci sotto il sole, mi sentivo come “attraversato” da una folla che, ogni giorno, ogni giorno, portava il peso della fatica, della vita, di una vita di lavoro e di ricerca di lavoro.
Ebbene, in quei giorni, mi sono ancor più convinto di quanto già non fossi prima del mio ritorno al lavoro intellettuale in queste terre, che la questione del rapporto tra i giovani e il lavoro sia soprattutto una questione “occidentale “ e che non riguardi il cosiddetto Sud del Mondo.
In primo luogo per come la si declina “da noi”, in società ormai a capitalismo finanziario dispiegato dominate, società che producono uno specialissimo e originale modello di ordine sociale. Modello generato essenzialmente del fatto che la produzione massiccia di rendite da intermediazione tra generazioni consente a gran parte dei giovani di ogni classe sociale – questo va sottolineato – di rimanere inattivi ben oltre quel “ ciclo di vita” un tempo contrassegnato come quello della” giovinezza” (e mai superiore ai venticinque anni circa d’ età), a differenza di quanto accadeva sino a una trentina di anni fa.
Questa “trentina d’anni “mi serve per tirare quella riga in terra che segna il passaggio italico da un capitalismo produttivo di plusvalore industriale – pubblico o privato che fosse – a un capitalismo improduttivo da grande impresa finanziaria o finanziarizzata e non più da grande impresa industriale diffusa, impresa via via scomparsa: tanto dal mercato, quanto – ed è qui il nocciolo di tutta la questione – dai modelli simbolico-valoriali fondati sul valore del lavoro che essa diffondeva dominando la costruzione ideologica della società.
“Il lavoro conferiva status sociale: non praticarlo sgretolava lo status generando anomia e dolore sociale”
Lo status si raggiungeva lavorando e accumulando nelle e tra le generazioni le risorse monetarie e simboliche dal lavoro. Il lavoro conferiva status sociale: non praticarlo sgretolava lo status generando anomia e dolore sociale.
Tutto il contrario di ciò che accade oggi nelle nostre società “ad occidente”, “a Nord del mondo”: società che sono passate per il capitalismo affluente (ricordate Claudio Napoleoni). E i valori “signorili” di quelle società ormai dissolte dal capitalismo finanziarizzato a bassa occupazione e a bassi salari hanno intriso le coscienze dei valori che quelle società hanno prodotto (ricordate Marcuse?). Valori che si conservano ancora oggi, nel sedimento inconscio delle mentalità collettive, anche ora che l’affluenza è scomparsa.
E sono scomparse le sedimentate generazioni tra loro unite dal landscape ideologico del lavoro fisso, tanto privato quanto da grande impresa, quanto dal lavoro pubblico-statale… e soprattutto dalla condivisione di una etica del lavoro fortissima e oggi scomparsa a livello di massa (da Marcuse a De Masi…).
La crisi del 2007 non porta che a conclusione i cicli storici di quell’industrializzazione italiana concentrata in grandi popolazioni attive sulle filiere tecnologiche e commerciali che entra in una crisi di riproduzione profonda.
Essa tracima nell’auto da fè dell’impresa pubblica e nella inserzione subalterna nella globalizzazione di quella privata. E così avanza sino a imporsi in un mondo che glorifica – coi potentissimi mezzi digitali – un cielo senza stelle ideologiche, un mondo di valori comportamentali diffusi – politicamente e culturalmente premiati – che sono l’esatto contrario di quelli del Nostro cielo: quello della micro, piccola, media e artigiana: impresa fondata sulla società naturale famigliare, con alta pluralità settoriale sia merceologica sia tecnologica nonostante la bassissima capacità di manovra finanziaria.
Un modello opposto a quello che si delinea sul fronte dei mercati e delle simbologie vitali umane osannati dai social, dalle televisioni, dagli studiosi dominanti le università dell’anglosfera, per i quali la storia era finita e la guerra (pensate un po’…) non poteva più manifestarsi nel mondo… perché il mondo era ormai una superficie levigata sempre in bilico tra il virtuale e il reale.
Nonostante questa vittoria del simbolismo signorile, tuttavia, il lavoro di famiglia, con la famiglia, in cui, per esempio, pur di continuare a vivere e lavorare nell’impresa e per l’impresa, si accetta e si pratica anche l’auto sfruttamento salariale (come si fa da sempre nelle cooperative sane e longeve).
Un mondo che si riproduce nella cultura del lavoro quale che esso sia, purché onesto e trasmesso da più generazioni. Un modello che si ritrova sempre diffusissimo nel mondo nelle società periferiche dominate dal capitalismo estrattivo in cui la popolazione e le generazioni tutte cercano ininterrottamente continuativamente “lavoro”. Dove persino il lavoro infantile non solo non è mal visto, ma ricercato e spesso organizzato non solo – come stupidamente si crede – dalla malavita, ma da organizzazioni benefiche not for profit spesso di matrice religiosa.
“Nel Sud del Mondo i giovani vogliono il lavoro. Lo cercano, se lo contendono e organizzano con le generazioni anziane tutte le occasioni grazie a cui è possibile lavorare”
Insomma: nel Sud del Mondo i giovani vogliono il lavoro. Lo cercano, se lo contendono e organizzano con le generazioni anziane tutte le occasioni grazie a cui è possibile lavorare. Perché questo è – nel Sud del mondo – il landscape dominante: il lavoro, il lavoro in ogni sua forma. Una ricerca di lavoro continua, disperata, che tracima nel fenomeno che sarà quello dominante del secolo che continua: le grandi migrazioni planetarie.
Un lavoro che quando lo si raggiunge salva perché dona dignità.
“Tutto diverso il mondo simbolico in cui viviamo. Qui il landscape è la leva finanziaria: è il fare molti soldi senza scendere in officina”
Tutto diverso il mondo simbolico in cui viviamo. Qui il landscape è la leva finanziaria: è il fare molti soldi senza scendere in officina.
Ancor più se figli di proprietari di quelle officine. Qui lo status symbol non è il lavoro comunque, come nelle terre del Sud del mondo, ma la vita senza lavorare comunque: in quello straordinario squilibrio di status registratosi a favore della finanza – tanti, molti e subito – rispetto a qualsivoglia altra attività, sia di studio e formazione secondo i cicli di vita , sia che rifletta in forma più o meno desiderata il paradigma normativo dominante creato proprio da quel mondo in dissoluzione di grandi imprese industriali e finanziarie prima ricordate. Insomma: tutto è cultura, è educazione. È il lavoro intellettuale e di comunicazione che attende le imprese ‘a Valore Artigiano’.
Giulio Sapelli
Giulio Sapelli, già Professore ordinario all’Università degli Studi di Milano ed editorialista, unisce economia, storia, filosofia, sociologia e cultura umanista in una sintesi originale e profonda. Ha insegnato in Europa e nelle Università delle due Americhe, in Australia e Nuova Zelanda. I suoi lavori sono stati tradotti in tutto il mondo.
E’ Presidente della Fondazione Germozzi ed è impegnato a valorizzare il concetto di Valore artigiano, che è forza di popolo, di persone e di imprese legate da uno spirito unico, il quale esprime la vocazione originaria incline alla creatività e all’amore per la bellezza.