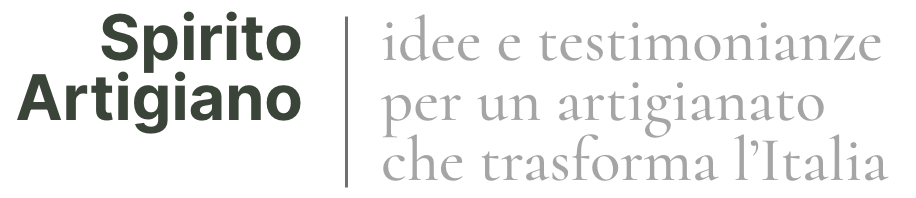Nella Phisiologie du gout Jean Anthelm Brillat Savaren, siamo agli inizi dell’800, scrive: “la gastronomia si occupa dell’uomo in quanto egli si nutre”.
Chi oggi ritiene che la questione sia faccenda da influencer, o da spettacoli televisivi a volte di stucchevole banalità, da pettegolezzo al sugo o da (finte) classifiche e da reali condizionamenti economici si rintana in una confortevole zona d’ignoranza. Oppure, per dare parvenza di pensoso spessore, si ricorre alla nutrizione stabilendo divieti, imponendo regimi dietetici, talvolta creando alla bisogna di qualche gruppo multinazionale questa o quella ricerca. Non va immune da quest’ andazzo neppure l’Oms e per spiegare molte cose – dalla bistecca creata in laboratorio alle meduse e agli insetti che l’Unione europea ci vuole mettere, bontà sua, nel piatto – si fa appello a nobili cause: il riscaldamento globale, la fame nel mondo, la finitezza delle risorse. Ottimo terreno di coltura per queste parole d’ordine che seguono pedissequamente il processo della finestra di Overton – si pone un concetto apparentemente non condivisibile come smettere di coltivare per salvare il pianeta e poi con un’ossessiva ripetizione e pochi aggiustamenti di azione politica lo si rende universalmente condiviso – è appunto l’ignoranza del fatto che la gastronomia richiede studio delle scienze sociali ed economiche, è manifestazione culturale-antropologica, è soddisfazione di un bisogno attraverso manipolazione tecnologica, è giusto sfruttamento agricolo delle caratteristiche di un territorio, è sedimento di esperienza e costituente di identità. Invece nei nostri giorni e con scopi che nulla hanno a che vedere col cibo si tende a ridurla a soddisfazione del bisogno (ancestrale e vitale) alimentare negando l’evoluzione che da almeno un milione e mezzo d’anni l’uomo ha compiuto dacché tracce della prima grigliata risalgono all’homo erectus e sono state trovate in Sud Africa. Da lì comincia un cammino che ci porterà alla fine del Paleolitico – più o memo dieci millenni fa – alla nascita dell’agricoltura e della civiltà come ancora la concepiamo. Tutto per un tozzo di pane!
Nella nostra disperata contemporaneità c’è chi lavora a distruggere l’agricoltura rescindendo il legame tra campo e piatto che è invece il cardine della gastronomia
La Food Foundation che è finanziata dalla WBCSD (è l’organizzazione delle maggiori società energetiche mondiali) ha convinto Oms, Fao e Onu che bisogna arrivare alla dieta mondiale – dunque ubiqua e omologata – anche attraverso i cibi distaccati dalla terra. Dicono al WBCSD che: “Un recente rapporto sull’industria alimentare ha previsto che la carne bovina prodotta in laboratorio, utilizzando un processo chiamato fermentazione di precisione, implicherà grandi cambiamenti per l’industria agricola, nonché per la salute umana e l’ambiente. Vasti appezzamenti di terreno agricolo potrebbero essere disponibili per altri utilizzi.”
Insomma bisogna usare la terra per metterci i pannelli solari e sostituire i cibi tradizionali con gli insetti, le meduse, le alghe che l’Ue autorizza al commercio, mentre lo United States Department of Agriculture ha concesso alle californiane Upside Food e Good Meat di vendere la carne di pollo ottenuta con la moltiplicazione cellulare nel bioreattore, mentre già in Israele le mamme nutrono i neonati non con il proprio latte, ma con quello che si ricava “spremendo” in un bio-reattore le cellule mammarie prelevate durante le mastectomie estetiche. Insomma gli scarti del chirurgo diventano pappa per i bebé e lo chiamano progresso.
Considerando che dieci società multinazionali – fatturano circa 5 mila miliardi di dollari – detengono nel mondo il monopolio alimentare e sono tutte impegnate nella produzione di cibo sintetico viene da chiedersi se non si ponga con urgenza una questione di democrazia alimentare. Si è soliti dire tra gli antropologi che si occupano di cibo che il cosiddetto “dilemma dell’onnivoro “ – straordinaria sintesi operata da Michel Pollan – ha aiutato l’evoluzione. Essere al vertice della catena alimentare – non se ne dolgano i vegani, ma sta scritto “quanto si muove e ha vita vi servirà di cibo: vi do tutto questo, come già le verdi erbe. Soltanto non mangerete la carne con la sua vita, cioè il suo sangue.” (Genesi 9: 3-4) – ha posto il Sapiens in continuo confronto con le opportunità di soddisfacimento del bisogno e il dover scegliere ne ha sviluppato il senso critico. Per capirci: sappiamo che l’amaro ci disgusta perché dalla amigdala (una mandorlina che sta nel cervello e ci dà emozioni e ci avverte delle paure) parte una remota informazione: le sostanze tossiche sono per la stragrande maggioranza amare.
E’ una stratificazione di consapevolezza dovuta all’esperienza a guidarci.
Solo noi contemporanei di fronte al dilemma dell’onnivoro lasciamo che ce lo risolvano le parole d’ordine e gli schemi di marketing! Le multinazionali del cibo lo sanno benissimo
Forse il più arguto e profondo socio-antropologo della nostra era, Claude Levy Strauss, ha posto le basi per la vera conoscenza del valore culturale del cibo quando in “Le buone maniere a tavola” – un saggio che compare nella sua opera più complessa: Tristi tropici – ha illustrato come l’evoluzione dell’uomo e la sua aggregazione sociale dipendano dall’evoluzione del cibo e del modo di prepararlo, sceglierlo e consumarlo.
Ci sarà modo, spero, di tornare a occuparci più in profondità di questo argomento decisivo, ma due notazioni di Levy Strauss appaiono indispensabili.
La prima è la distinzione tra crudo e cotto e tra arrostito e bollito che si portano dietro l’opposizione natura-cultura (a tal proposito un secolo e mezzo prima di Levy Strauss Brillat Savarin scrive: nasciamo rosticcieri e diveniamo cuochi) la seconda è la classificazione dei cibi sotto-forma di gustemi.
Che significa? Come per la linguistica le parole sono fonemi così per l’antropologia del cibo i sapori sono gustemi. La composizione delle parole produce frasi che esprimono concetti, i sapori composti nei piatti esprimono valori culturali e perciò sono espressioni identitarie. Si spiega così l’immensa varietà di modi di acconciare il cibo. Un caso del tutto particolare è l’Italia che ha lingue, popolazioni, colture e culture diversissime da valle a valle al punto che si dovrebbe parlare di cucina italica piuttosto che di cucina italiana. Lo stesso Pellegrino Artusi quando compilò il suo “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” non dette una definizione compiuta delle ricette della penisola mancandogli gran parte della gastronomia meridionale peraltro magistralmente raccolta da Ippolito Cavalcanti primo codificatore degli spaghetti con la pummarola anche se un sugo di pomodori già compare a fine 600 ne Lo Scalco alla moderna di Antonio Latini. Abbiamo dovuto aspettare Ada Boni col suo Talismano della felicità e poi la Gosetti della Salda con le sue “Ricette regionali” per avere un panorama gastronomico nazionale sufficientemente compiuto. La ragione è semplice e complessissima allo stesso tempo.
Servono i gustemi di Levy Strauss a dirci perché mangiamo come parliamo, ma serve un’indagine profondissima che incrocia agricoltura e società per dirci perché mangiamo in modo tanto differente
Non necessita essere scienziati per capire – ed è solo un esempio – perché lungo la via Emilia – 230 chilometri che percorrono tutta la regione dai tempi di Marco Emilio Lepido – s’ incontrano gli anolini di stracotto di Piacenza e di Parma, i tortelli d’erbe di Reggio Emilia, i tortellini di Modena e quelli di Bologna, i tortelli di zucca ferraresi, i cappelletti di Romagna. Si va dallo stracotto vero di Piacenza al sugo di arrosto a Parma, all’erba di Reggio, al prosciutto di Modena, alla mortadella di Bologna, all’ortaggio principe della bassa, al raviggiolo formaggio fresco e povero in Romagna. E’ il censo e il campo che determinano le varianti di queste paste ripiene.
Partendo da qui si avverte l’urgenza di costituire e costruire una codificazione non già dei prodotti che esiste anche se sarebbe necessario portarla a sintesi, ma dei produttori e delle ragioni che hanno portato a quella produzione. Non v’è dubbio che i veri custodi di questo sapere e di questo saper fare siano gli artigiani.
Nel paniere delle Dop e Igp abbiamo moltissimi prodotti tal quali cioè appannaggio della sola sapienza contadina, ma larga parte sono frutto di trasformazione, anzi meglio di manipolazione. Di sapienze artigiane che dal casaro, al fornaio, dal beccaio, al salumaio, dal frantoiano al cantiniere hanno costruito quel tesoro che oggi chiamiamo made in Italy, ma che in realtà è la dispensa italica. Vi sono alcune tecniche appannaggio solo degli italiani, anzi appannaggio solo di alcuni territori italiani. Si pensi alla pasta filata: le mozze, le provole, le scamorze, i caciocavallo sono frutto di abilità stratificatesi nei secoli. Pensiamo alla panificazione: i censimenti più restrittivi indicano 250 differenti tipi di pane che sono in realtà quasi il doppio. Dipende da cosa? Dai grani, dall’uso alimentare che se ne è fatto nei secoli, delle aggregazioni di comunità. Un censimento dei salumi ci porta a 360 diversi prodotti, ci sono almeno 500 differenti ricette tra conserve, confetture e preparati d’orto. L’elenco potrebbe essere veramente sconfinato. Dietro ognuna di queste preparazioni ci sono invariabilmente un artigiano e una sapienza che è stata trasmessa di comunità in comunità. Un caso mirabile è quello dei formaggi grana. Li hanno “inventati” i monaci cistercensi.
Peraltro alle comunità monastiche, dopo San Benedetto dunque dalla fine del sesto secolo, si deve la rinascita della sapienza agricola, ma anche o soprattutto dell’artigianato gastronomico. Tornando ai cistercensi si sa che a Chiaravalle poiché grazie alle marcite (la coltivazione del fieno nelle pozze di risorgiva che garantiva fino a cinque sfalci l’anno) si aveva molto latte venne inventato il formaggio iperstagionato per conservare il latte in eccesso. Così si può dire delle alici in botte frutto della flottiglia di pesca dei cistercensi dell’antica Canonica di San Pietro a Tuczolo, sull’omonimo colle vicino ad Amalfi. Lo stesso vagando tra le ricette e soprattutto tra i dolci tradizionali (si pensi alle sfogliatelle napoletane) troveremmo che sono frutto di opera monastica. Ma proprio questo radica che il prodotto nasce da un’abilità codificata capace di incrementarne il valore agricolo attraverso la trasformazione.
Un recente studio condotto da Symbola mette in rilievo che il 94% dei prodotti Dop Igp italiani si fanno o si originano nei comuni al di sotto dei 5 mila abitanti dove sovente (siamo al 64% dei casi) la produzione artigiana è la sola economia presente. Come si spiega? Probabilmente è necessario scandagliare la Storia dei nostri agglomerati urbani. Sappiamo che le Arti, o Collegi o Paratici o Fraglie a seconda delle regioni o Gilde rifacendosi alla codificazione francese, furono l’architrave della municipalità medioevale. Vi era in queste una rigida divisione del lavoro. Basti pensare che a Bologna beccai (macellai di bovini) non potevano invadere il lavoro dei salsamentari (confezione di carni suine) e che per esempio un salume come la mortadella che richiedeva arte gastronomica era pagato 8 volte il prezzo del prosciutto. E’ solo un esempio per far comprendere quanto l’abilità che diverrà poi nel Rinascimento la molla dello sviluppo incideva sulla percezione del valore e come la filiera campo-allevamento-trasformazione del suino avesse già una funzione di moltiplicazione del valore però con una stretta dipendenza degli attori tra di loro. E c’è il terminale ultimo che oggi diventa centrale: il facitore di cibo.
In Italia si è ritenuto che la ristorazione dovesse essere tutta contenuta nell’ambito della somministrazione. Questo è un errore che si rivela esiziale proprio oggi.
Ripensare la funzione e la collocazione del ristoratore e ancora di più restituire la cuoca e il cuoco alla sua vera natura artigianale è indispensabile
Anche qui soccorre la storia. E’ convinzione diffusa che le Tabernae e i Thermopolia siano le progenitrici dei ristoranti. In realtà esse sono piuttosto le progenitrici delle locande e dei negozi di alimentari. Il ristorante come lo conosciamo oggi è più figlio di una crisi e in particolare di quella della media aristocrazia in conseguenza, al Sud, della caduta del regno borbonico, al Nord dell’espansione del Regno d’Italia. Sono i monsù ad aprire i ristoranti, sono gli scalchi a farsi cuochi pubblici. Non sfuggirà che per secoli – quella si è diretta derivazione dal mondo prima etrusco e poi latino – il banchetto prevede una messa in scena che richiede abilità artigiane di altissimo profilo. Basterà ricordarsi dello scheletro in argento che brandisce verso i commensali Trimalcione – come riferisce Petronio Arbitro nel suo Satyricon – o del fatto che Leonardo da Vinci viene assunto da Ludovico il Moro come maestro delle cerimonie e regista dei banchetti, ruolo che era appunto dello scalco (uno famosissimo fu messer Cristofaro Messisbugo alla corte estense di Ferrara). A metà dell’800 i monsù (storpiatura da monsieur) cuochi alle corti minori borboniche dove ci si piccava di mangiare alla francese in una fusion mediterranea (il timballo del Gattopardo è eccelso esempio di quella cucina) si trovano disoccupati e aprono le loro case all’ospitalità gastronomica o si trasformano in cuochi a domicilio. Quella è la nascita della moderna ristorazione – verrà codificata da Cesar Ritz – che ha uno straordinario antesignano in Antonio Nebbia: col suo Cuoco maceratese pubblicato in prima edizione nel 1779 offre lo spaccato della cucina di corte che si fa borghese e diventa menù di ristorante. E’ oggi indispensabile recuperare questa dimensione altamente artigiana del produrre emozioni e prodotti gastronomici. Per almeno tre buone ragioni. La prima è di carattere economico generale.
L’Italia ha nell’export agroalimentare uno dei suoi pilastri. La cucina italiana nel mondo è stata fondamentale per vendere il vino e gli altri prodotti. Solo che è ancora priva di un’effettiva certificazione e sovente è orfana di “braccia” italiane. La seconda ragione risiede nella necessità di riannodare tutta la filiera dal campo alla tavola negli ambiti territoriali definiti e nei luoghi soggetti allo spopolamento (si pensi alle zone montane; una terra di sperimentazione di questo progetto può essere senza dubbio il vastissimo cratere del sisma del 2016 nel Centro Italia) dove le attività produttive artigianali possono una volta integrate con le attività di ospitalità e di messa in valore del territori costituire un nuovo volano di sviluppo mettendo a leva il turismo.
Il progetto arti-turismo questo è: porre al centro dello sviluppo e della valorizzazione di un territorio l’impresa artigiana che è contemporaneamente magnete attrattivo, dispensatore d’esperienza e diffusore di valore attraverso la declinazione gastronomica (e ovviamente della residenzialità) che diventa testimonianza dell’esperienza culturale. La terza e più urgente ragione sta nell’attacco violento che le multinazionali della nutrizione stanno facendo alla tradizione gastronomica col doppio intento: di eliminare la fase agricola e di omologare il gusto. Siamo già dentro un’epoca in cui basta un micro-onde, un posto carino e un ottimo fornitore di cibi precotti per aprire un “ristorante”. Ovviamente si tratta di mera somministrazione o, come più argutamente si dovrebbe dire, di spaccio di calore.
Per contrapporsi a questa deriva ecco nascere la Cuoca e il Cuoco d’Arte o, con un’accezione meno suggestiva, l’Arti-chef. Si tratta di un maestro di cucina che prepara i cibi con le proprie mani nel virtuosissimo ridotto passaggio campo-tavola oppure campo-artigiano del gusto -tavola
E’ l’esempio di chi si fa la pasta da solo, di chi sceglie i prodotti dell’orto o della pesca e li trasforma grazie alla sua abilità, è l’esempio di un’impresa artigiana terminale del lavoro di altre imprese artigiane: del macellaio, del panettiere, del salumiere, del casaro, dell’ortolano, del vignaiolo, del frantoiano, del pasticcere. Ma tutti legati però ad un medesimo disciplinare di qualità territoriale. Ci sono due strade che portano al Cuoco d’Arte: la prima è la quasi totale produzione in proprio, la seconda è la combinazione produttiva/creativa di fattori che arrivano dalla prossimità. Nell’un caso come nell’atro protagonista del processo è l’abilità di trasformazione che anche nell’ambito gastronomico perfettamente incarna la definizione di artigiano secondo l’Accademia della Crusca: “Chi esercita un’attività lavorativa a livello famigliare o con un apporto limitato di operai, per la produzione di beni o servizi e di oggetti non di serie, artistici o no.” Nel nostro caso il Cuoco d’Arte è un produttore di beni culturali! E’ di tutta evidenza che una tale articolazione mette il ristorante del Cuoco d’Arte nella condizione d’essere anche l’aggregatore di altra impresa artigiana: quella che produce i piatti, i bicchieri, i tessuti. Tutte imprese che devono essere coinvolte nel circuito del Cuoco d’Arte proprio per dare sostanza all’originalità della proposta. Fermo restando che il servizio di sala, l’accudimento del cliente – che è centrale tanto quanto la cucina – resta un’attività di somministrazione e dunque commerciale. I riflessi dal punto di vista organizzativo, normativo, di formazione dell’esistenza di una figura come il Cuoco d’Arte sono a tutta prima percepibili. Esiste peraltro un esempio che si è radicato in Francia che sono i ristoranti che espongono la sigla “fait maison” che traduciamo efficacemente in “fatto in casa”. Se ne avvantaggiano soprattutto i piccoli hotel che puntano sul fait maison per la colazione e le trattorie regionali. L’idea del Cuoco d’Arte è più complessiva e ambiziosa: si tratta di restituire pieno valore alla manualità che si sposa con la creatività e poggia su una cultura di tradizione e una conoscenza profonda del territorio per elaborare un’ offerta identitaria. Per dare sostanza a tutto questo serve la creazione di un circuito, di una guida anche replicata in internet e agganciata ad una app, serve la costituzione di un disciplinare e una forte spinta di comunicazione. Ma è sostanzialmente la vera cucina che chiede questo intervento di recupero dei suoi valori abbandonata com’è al vento delle mode e sottoposta al ricatto del profitto fine a sé stesso.
© 2024 Spirito Artigiano. Tutti i diritti riservati.
Carlo Cambi
Ha esordito nel giornalismo giovanissimo. È una delle prime firme del quotidiano «Libero» e del «Qn». Ha scritto per il «Tirreno», «la Repubblica», «Panorama», «Epoca», «L’espresso», «Affari & Finanza», «Il Venerdì di Repubblica». Ha fondato e diretto «I Viaggi di Repubblica». È stato insignito di importanti premi tra i quali il Premio Internazionale Ais-Oscar del Vino nel 2009, quale migliore giornalista e scrittore del vino. È stato uno dei volti della popolare trasmissione di Rai 1 La Prova del Cuoco e ospite fisso alla trasmissione Uno mattina verde (RAI 1).
È tra i fondatori del Movimento Turismo del Vino. È sommelier ad honorem dell’AIS e socio corrispondente dell’Accademia dei Gergofili. È stato insignito di numerosi riconoscimenti e premi accademici e giornalistici, tra cui l’Oscar del Vino e il Verdicchio d’Oro.
È autore delle guide del Gambero rozzo e del Mangiarozzo. Tra i suoi ultimi libri, Le fonti raccontano (Retecamere, 2010), 101 osterie e trattorie di Milano (Newton Compton, 2010), 365 ricette della cucina italiana (Newton Compton, 2012) e Il picchio e la vigna (Camera di Commercio di Macerata, 2013)