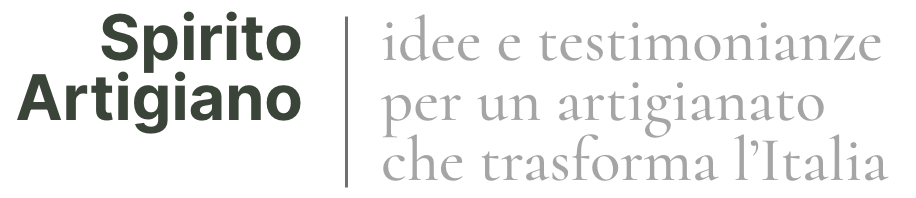Il senso di questo libro sta tutto nelle prime pagine e in una parola: congiunzioni.
Congiungere vuol dire porsi in relazione, ossia trasformare in atto la potenza che è insita nella vicinanza, nella contiguità, nella sistemica interrelazione: la congiunzione, appunto.
E congiungersi implica ben più di un incontro e di uno scambio: congiungersi- per usare il linguaggio à la Marcel Mauss un tempo caro a chi studiava di relazioni sociali e quindi anche di economia- congiungersi implica uno scambio non di mercato.
E lo scambio non di mercato è cooperazione, condivisione, integrazione, nel distinto operare, però, di unità organizzative e di aggregazioni personali tanto nei mercati quanto nei quasi mercati e infine nelle assenze di mercato , ossia nello scambio di valori, di culture intese come mores e diverse da quello che si apprende nei processi di civilizzazione: ossia concetti, pratiche di azione, costruzione di tecnologie e di relazioni funzionali e procedurali apprese nelle agenzie statali istituzionali che diffondono o dovrebbero diffondere qualsiasi sorta di modello di “addestramento” oppure di “formazione” dell’umano.
Non vi è mondo in cui tante congiunzioni si siano spezzate come L’Italia, l’Italia che abbiamo amato e che amiamo perché, diremo con Cesare Pavese: “amiamo gli italiani”. Un amore “singolare” per “i più dominanti”(che invece detestano gli italiani e parlano spesso inglese anche tra italiani), un amore che non ha mai avuto molta fortuna …in Italia, Giuliano Procacci -in tempi ormai lontani- scrisse una storia degli italiani e non a caso la scrisse in prima istanza per un editore francese…
Ma veniamo alle congiunzioni manfrediane: si tratta di congiunzioni tra organizzazioni, congiunzioni economiche e non, ossia economiche e funzionali e socio-culturali .
Il libro discute di quelle funzioni che dovrebbero essere proprie delle istituzioni e che dovrebbero essere lo scheletro e la struttura muscolare di un costrutto economico sociale che, quando è costruito-appunto-su un territorio storicamente determinato ed è abitato da popolazioni stabilmente insediatesi ed é in grado di culturalmente accogliere nuovi insediamenti che si costituiscono in una comunità di destino e quindi crea, per far ciò, le sue istituzioni lega -burocratiche: ebbene, allora, tutte quelle funzioni e pulsioni sono lo stato: lo stato che in tal modo dà forma a una nazione.
Ciò è avvenuto in Italia sino a un paio di secoli orsono, assimilando nuove popolazioni, per poi, a contrario, iniziare una densa storia di emigrazioni in tutto il mondo: ecco gli italiani fuori d’Italia, gli Italici di Piero Bassetti.
L‘ Italia, ci ricorda Manfredi, è stata tanto uno stato quanto una nazione a tardiva unificazione: ma, nel contempo, una “nazione culturale” a precocissima, lunghissima e altissima tradizione
E’ uno di quegli stati, l’Italia, che non si costruiscono per secoli a partire dalle fondamenta ma dal tetto, dalla cultura e dalla lingua… le fondamenta via via s’aggregano attorno a ceppi originari e così via via avanzano verso il cielo , sino a quando per processi storici originali, nella storia mondiale, non si riconoscono in uno stato unificante , ossia in una comunità di destino che assurge hegelianamente al tetto di quella casa, che prende appunto il nome di stato.
Il tetto allora dovrebbe risplendere in tutto il suo magnificare la bellezza e irrorarne le fondamenta
Così non è stato… ed è quella originaria, possibile congiunzione, che dà l’inizio a tutte le altre congiunzioni non inveratesi e qui descritte…
L’Italia ha via via accumulato e diffuso nel mondo per secoli e secoli le sue altane culturali, magnifiche e universali, ma ha costruito tardivamente, recentissimamente il “suo”stato …sino a oggi: nei decenni in cui ha iniziato a distruggerlo scientemente, per volontà politico-istituzionale, nell’agone della centralizzazione capitalistica mondiale in cui si è inserita in guisa subalterna.
E’ in questa temperie che ha costruito e decostruito continuamente -l’Italia-il suo patrimonio manifatturiero-industriale, similmente a quanto si è fatto per la costruzione di quello specialissimo intreccio tra stato e nazione: prima il tetto, la cultura (i grandi intellettuali che inventano via via la lingua che sarà “nazionale” e poi le fondamenta, ossia le mura, le istituzioni che consentono al tetto di reggersi e di non precipitare ogni volta che si leva il vento).
Per l’industria si intrecciano fenomeni di permanenza manifatturiera secolare con le tecniche dei tempi che via via si aggiornano e si trasformano e soprattutto si aggregano, disgregano e riaggregano continuamente, in agglomerati di imprese in forme diverse: reti, insediamenti dominanti, relazioni, grazie alle reti, tra insediamenti che non sono più solitari e le piccole unità organizzative che hanno nelle società naturali –in primis le famiglie – la loro sostanza costitutiva.
Manfredi accentra la nostra attenzione sugli insediamenti secolari della campagna urbanizzata e delle piccole città, la Sua provincia: questo processo complesso, antichissimo e modernissimo al contempo, che si crea e ricrea e che avviene ogni volta grazie all’interrelazione tra quella che Lui chiama – appunto – provincia e quella che tutti chiamiamo città, piccola città, per distinguerla dalla metropoli.
Feconde di culture primigenie, le provincie, conservano la bellezza della tradizione che incontra le tecnologie, i denari, le capacità personali non originarie e naturalmente trasmesse in società grazie alle comunità che nelle società si riproducono sempre ( in scacco di ogni visione neoclassica dell’economia, economia che non può separarsi, anche teoricamente, dalla società).
Si tratta di una forma storica diversa di trasmissione dei saperi pratici e teorici uniti nelle azioni, forma diversa da quella che avviene istituzionalmente nelle agenzie della formazione umana tanto pubblica quanto (oggi dilagante) privata, sotto forma di università, master, corsi formativi, ecc.
Le città – e Milano per Paolo Manfredi è la “città delle città” infusa di un potere salvifico in potenza – sono qui magnificamente descritte per quel che sono e che Marino Berengo ci raccontò magistralmente da par Suo negli scritti sulle città europee: incunaboli delle borghesie e incunaboli del sapere capitalistico via via che questo si formava nella produzione di plusvalore
Città borghesi perché città produttrici di stratificazioni sociali fervide, di comunità di cuore e di ingegno, e circolazioni di merci e denari e di racconti, di landscape ideologici potenti su questi valori e amori.
La Provincia vive scambiando risorse materiali e capacità personali in un rapporto tra centro e periferia che funzionò per secoli come osmosi quasi perfetta, perché protetta dalle istituzioni. Istituzioni che sono, spesso, più appartenenti e prodotte dalla periferia che dallo stato centrale.
Di qui la forza di una congiunzione che pare potersi non interrompere dopo la grande crisi tutta autoctona (non da ”globalizzazione” e ben prima di Maastricht) degli anni Ottanta del Novecento, che tutti dimenticano( per spostare l’ accento ed eliminare i borghesi sensi di colpa), sugli anni Novanta, invece, del Novecento, incentrati sulla distruzione dei partiti con la doppia mossa del cavallo della centralizzazione capitalistica europea promossa dal capitalismo anglosferico che – non a caso – inizia in Australia, continua negli USA di Clinton e ha la sua acme nella Gran Bretagna di Tony Blair (e che è chiamata “globalizzazione”).
La realtà fu ben diversa: negli anni Ottanta del Novecento tutti i tentativi di inserzione non subalterna nel mercato mondiale da parte delle grandi imprese italiche (Pirelli, Fiat, Banca Commerciale Italiana, Montedison di Schimberni, ecc.) si infransero contro la volontà di imporre all’Italia un’inserzione -invece-subalterna, tanto nella globalizzazione, quanto nell’UE
La viltà della grande borghesia industriale italiana blandita da una Mediobanca arroccata sulla difesa delle grandi famiglie fece il resto.
E così cadde la congiunzione che sosteneva la crescita italiana, dal boom sino agli anni Ottanta del Novecento, quando iniziò a profilarsi un declino che è stato poi inarrestabile
Il libro parla da sé: ormai una sterminata bibliografia ne rafforza le idee centrali che sono tuttavia originalissime e coraggiose
Manfredi insiste su un tema a me, a Noi sostenitori della tesi di Edith Penrose, assai caro: ossia la convinzione che ciò che costituisce il segreto delle buone performaces d’impresa non siano le dimensioni di scala, ma le capacità manageriali, intese come comunità di tecniche di organizzatori e di imprenditori che nell’impresa come costrutto sociale, costrutto di congiunzioni, operano.
Esse mirano a produrre plus-valore, quale che sia la dimensione di scala: piccolo non è bello: è possibile ed è migliore se congiunto con le forze della grande impresa e delle grandi infrastrutture del pubblico potere ben ordinato.
Oggi questa teoria è potenziata all’ ennesimo grado dalle nuove tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale: esse forniscono agli imprenditori, ai manager, ai tecnici tutte le strutture di relazione possibili con il mondo degli affari e dalla costruzione degli stocks di capitale fisso in una dimensione prima inimmaginabile
Ma l’Italia non possiede uno stato che non sia illusorio e vessatorio quando appare.
Il tutto in una inserzione subalterna nei grandi capitalismi sovranazionali
Un’ inserzione che ha distrutto quello che costituisce di ogni stato il sistema nervoso e sanguigno: ossia le sue articolazioni periferiche: comuni, provincie, relazioni funzionali con i corpi intermedi
In Italia, per la furia liberista -ideologica e culturalmente subalterna in gran misura-si è distrutta l’articolazione benefica e secolare delle Camere di Commercio, delle Provincie, e di tutte quelle forme di dell’industria e dei servizi proprietà che ora si denominano “di capitalismo paziente” e che io per anni, nelle mie lezioni in Via Festa del Perdono 7 in Milano, mi ostinavo, invece, a descrivere come forme poligamiche di allocazione dei diritti di proprietà, dalle banche cooperative e popolari alle cooperative di produzione e lavoro sino alle forme miste di imprese municipalizzate pubblico-private: lezioni a cui il giovane Manfredi io credo molto abbia appreso negli anni in cui possedevamo il divino dono goethiano della giovinezza e della maturità e leggevamo Giovanni Montermartini primo tra tutti.
Ma veniamo al vizio d’origine: a quella subalternità italica prima richiamata che sarà un case studies che, per secoli, illuminerà le menti su ciò che non si deve fare nel percorso umano di produzione di quel surplus che può consentire alle società di sopravvivere benevolmente.
E qui forse la penna e il cuore di Manfredi avrebbero dovuto essere più severamente incisive per sottolineare, ancora, una volta la viltà dei dirigenti dei vertici ministeriali e dei grandi comuni e delle grandi imprese, i quali, dinanzi a questa distruzione istituzionale e culturale, non solo non hanno opposto resistenza, ma di essa sono stati i cantori e financo i fautori.
La meditazione di Manfredi intravede la via della ricostruzione
La via è quella di Guido Dorso: quella dei “cento uomini forti“, di “ferro”, i quali possono con la loro perseverante audacia colma di cultura e di amore, risolvere ogni problema.
La via è quella delle forme pazienti di proprietà associata di cui anche i corpi intermedi devono farsi organizzatori.
Luca Meldolesi e Fabrizio Barca, sulla scorta del grande Hirschman, hanno da anni percorso strade ben articolate fondate su questo progetto di costruzione di nuove élite, perché di questo in fondo, di nuovo, si tratta.
Io stesso mi sono esercitato sul tema negli anni lontani dei miei studi sulla Sardegna… e oltre.
Anche a me pare la strada giusta: severa ma non impossibile.
Il problema è sempre lo stesso: il “regista collettivo” che ponga sul terreno le macchine e gli operai e inizi il lavoro in comunità, lavoro che sarà lungo, faticoso, ingrato; ma, io credo- perché credo negli italiani-vittorioso.
Giulio Sapelli
Giulio Sapelli, già Professore ordinario all’Università degli Studi di Milano ed editorialista, unisce economia, storia, filosofia, sociologia e cultura umanista in una sintesi originale e profonda. Ha insegnato in Europa e nelle Università delle due Americhe, in Australia e Nuova Zelanda. I suoi lavori sono stati tradotti in tutto il mondo.
E’ Presidente della Fondazione Germozzi ed è impegnato a valorizzare il concetto di Valore artigiano, che è forza di popolo, di persone e di imprese legate da uno spirito unico, il quale esprime la vocazione originaria incline alla creatività e all’amore per la bellezza.