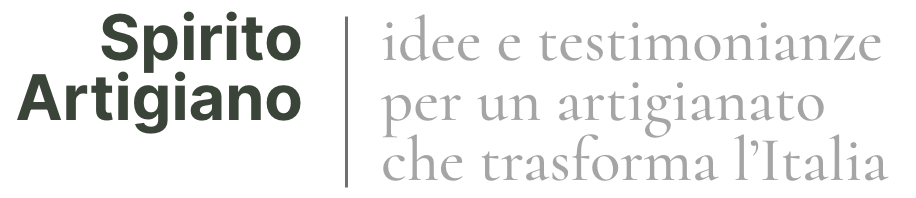La cultura dell’impresa diffusa può rappresentare una risorsa straordinaria in tempi incerti, difficili e di cambiamenti rapidi e violenti come gli attuali.
È questo uno dei temi principali emersi dalla plenaria di EECOLE, la comunità di policy dell’OCSE che si occupa del rapporto tra formazione, innovazione e sviluppo locale, e che il 24 novembre ha riunito a Parigi insieme ad ERIA, il centro di ricerca dell’ASEAN e Est Asia, oltre 100 esperti, studiosi e policymakers provenienti da ogni continente. Confartigianato era presente, unica associazione di rappresentanza di impresa.
Da tempo, EECOLE anima momenti di confronto e interventi sul campo nei paesi OCSE per costruire ecosistemi nei quali le università e le istituzioni educative superiori possano sostenere lo sviluppo territoriale, intervenendo positivamente sul tema cruciale delle competenze. Un tema, peraltro straordinariamente presente anche nel contesto italiano, che oggi costituisce il principale ostacolo alla transizione, digitale e sostenibile, delle imprese e dei territori. Anche laddove le traiettorie di sviluppo, individuali e collettive, sono, compatibilmente con l’incertezza imperante, sufficientemente chiare, ovunque si avverte la mancanza di quel saper fare, nozione ben presente al mondo artigiano, che permette di realizzare quanto immaginato.
Nel pieno di una curva ascendente dello sviluppo tecnologico e del bisogno di mettere in campo soluzioni nuove a tutti i livelli per uscire dall’impasse, dunque, tutto il mondo riflette sulla scarsità di persone che quello sviluppo possano interpretarlo e renderlo valore quotidiano.
Uno spreco inaccettabile di risorse, poiché a fianco a questa mancanza di competenze si assiste a un fenomeno, come quello dei giovani completamente sconnessi da ogni attività formativa e/o produttiva (i NEET – not in Education, Employment or Training), una “generazione perduta” secondo la definizione di Mario Draghi, per la quale l’Italia ha il triste primate dell’UE con il 25,1%, ben dieci punti al di sopra della media.
Da qui l’urgenza, italiana ma più generale, si pensi alle aree interne di tutto il mondo, in cui la mancanza di competenze impedisce anche solo di immaginare azioni per contrastare la periferizzazione e la marginalizzazione, di porre in essere interventi che incidano positivamente prima che sullo stock di competenze tecniche (comunque necessario), sull’attitudine di tutti i soggetti a guardare positivamente, creativamente e con spirito costruttivo e fattivo all’epoca della “permacrisi” e del cambiamento continuo. È questa la sostanza di quella mentalità imprenditoriale (entrepreneurial mindset) che è emersa dall’incontro come il contributo più significativo che il mondo dell’istruzione superiore può fornire allo sviluppo di territori e imprese oggi.
Non si tratta necessariamente e solo di incentivare nei giovani la creazione di impresa come prospettiva di lavoro, tema che comunque rappresenta un valore anche economico e occupazionale fondamentale, ma più in generale di intervenire sin dall’istruzione elementare sullo sviluppo di quelle competenze soft che aiutano i giovani ad essere più creativi e aperti al cambiamento, che necessariamente include una componente di rischio. Nessuna organizzazione oggi, indipendentemente da dove opera, può infatti permettersi di ancorare la propria cultura e i propri meccanismi operativi ad attitudini burocratiche di avversione al cambiamento, formalismo, conservazione. Vale per le imprese ovviamente, che rischiano di essere spazzate via dalla successione di rivoluzioni che stiamo vivendo, vale per i territori e le organizzazioni non di mercato, che rischiano di rappresentare un freno allo sviluppo.
La mentalità imprenditoriale, è emerso chiaramente nell’incontro dalle testimonianze di docenti ed esperti dal Canada alla Corea, dall’Australia all’Inghilterra, si può insegnare ma richiede grande dedizione e attenzione, superiore a quella richiesta dalla trasmissione di competenze formali. Competenze formali che, in assenza di un’attitudine positiva al cambiamento, rischiano però di essere sostanzialmente inutili, dacché è sempre più raro che un lavoratore possa limitarsi a svolgere il proprio compito nel vuoto, come era nella fabbrica novecentesca.
Cosa c’entra il valore artigiano in tutto ciò? Moltissimo, ed è quanto è stato ribadito anche nel corso dell’incontro.
L’impresa diffusa, indipendentemente dalle dimensioni, e la capacità di fare gemmare nuovi imprenditori a partire dai garzoni di bottega, due componenti fondamentali del valore artigiano, rappresentano infatti casi di scuola di quell’entrepreneurial mindset a cui oggi si guarda come a un farmaco per le nostre economie e società malate. Malate anche perché hanno attraversato due rivoluzioni, quella fordista prima e quella dei servizi poi, che hanno marginalizzato proprio quel valore di imprenditorialità. Nella grande fabbrica, nei grandi uffici, l’attitudine a inventarsi il lavoro e a pensare fuori dagli schemi era un problema, non un valore.
Declinato in chiave digitale e di sostenibilità (concetto ben presente alle imprese nate anche in comunità certo non dedite allo spreco di risorse), il sistema di valori dell’imprenditorialità diffusa può rappresentare un vaccino contro il declino materiale e morale delle nostre società nell’era della crisi permanente.
È un patrimonio quasi genetico del mondo artigiano, che oggi deve essere rivendicato con orgoglio.
Foto di Skyler Ewing da Pexls
Paolo Manfredi
Milanese, 50 anni. È consulente per la Trasformazione digitale, ideatore e responsabile del progetto Artibici e responsabile del Progetto speciale PNRR di Confartigianato Imprese. Ha studiato Storia contemporanea. Scrive di innovazione, politica e ristoranti. È autore di “L’economia del su misura. Artigiani, innovazione, digitale” (2016), “Provincia non Periferia. Innovare le diversità italiane” (2016) e di “L’eccellenza non basta. L’economia paziente che serve all’Italia” (2023). Da settembre 2019 cura il blog “Grimpeur. Scalare la montagna dell’innovazione inclusiva” sulla pagina web di Nòva del Sole 24 Ore.