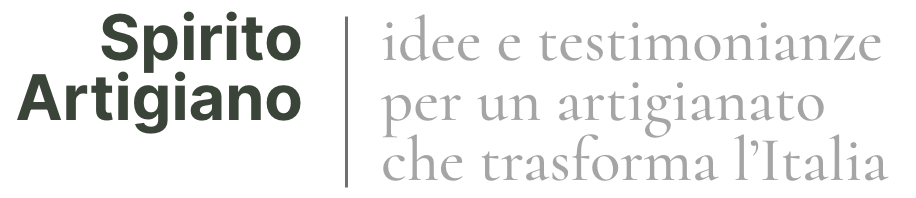La demografia è un problema prima di tutto economico. E’ stato molto chiaro, su questo punto, il direttore generale del Censis Massimiliano Valerii durante l’assemblea di fine anno di Confartigianato. Un concetto, quello del saldo demografico, sul quale anche il presidente Granelli ha riflettuto a lungo e che sta interrogando molti esperti della materia. D’altra parte, se già il nostro sistema economico sconta alcuni gap di competitività rispetto ad altri europei ed extraeuropei, quello della demografia rischia di essere un ulteriore fattore di squilibrio negativo. Ma il problema è molto più profondo e di non facile risoluzione. Di più: non riguarda solo il mondo delle imprese, ma è un problema che attiene alla tenuta strutturale del nostro Paese. Un’Italia sempre più vecchia, fragile. Di questo e molto altro si è occupato Alessandro Rosina, docente di Demografia e Statistica sociale all’Università Cattolica di Milano in molti dei suoi lavori[1]. Alessandro Rosina, peraltro, è autore – per Fondazione Germozzi – del nuovo ‘quaderno’ tematico della Fondazione dal Titolo ‘La crisi demografica italiana: giovani e qualità del lavoro – Idee, spunti, dati e scenari per affrontare gli squilibri che rischiano di compromettere lo sviluppo economico e la sostenibilità sociale del Paese’(scarica il volume).
Gli studi compiuti da Rosina forniscono una proiezione, a tratti, piuttosto allarmante del problema demografico in Italia. Forse, però, la cosa più desolante è che a fronte di questo scoglio che sta via via diventando sempre più insormontabile, in questi anni abbiamo assistito a una sorta di grande rimozione collettiva. Come se il problema non ci riguardasse. Se a questo aggiungiamo che le politiche messe in campo per fronteggiare la questione demografica si sono rivelate del tutto inefficaci, ecco che il quadro appare ancor più a tinte fosche. La sfida dell’inversione del trend è attuale, attualissma. Una sfida per il futuro.
Nell’intervista che Rosina ha rilasciato a Spirito Artigiano, cerchiamo di capire lo stato dell’arte, tentando di individuare una via d’uscita da un vicolo che, apparentemente, pare condurci in un’unica direzione: il vuoto.
Professor Rosina, lei sostiene che quella demografica sia una questione che il Paese abbia dimenticato. Perché e da cosa è determinata questa amnesia?
«E’ senz’altro la grande questione rimossa del nostro paese. Non mancano i titoli di forte preoccupazione sui media quando escono i dati Istat sulle nascite in continua riduzione, ma dal giorno dopo il tema scivola sistematicamente ai margini del dibattito pubblico. La politica italiana tende ad avere uno sguardo corto, che fatica ad andar oltre il consenso da ottenere nelle prossime elezioni.
La combinazione tra poca lungimiranza, bassa consapevolezza delle conseguenze della denatalità, marginalità delle politiche per i giovani e le donne, ha portato gli squilibri demografici a diventare sempre più gravi generando un senso di impotenza verso un destino ineluttabile. Anziché produrre una reazione si è via via scivolati verso la rassegnazione.
Ci siamo permessi di sottovalutare questa enorme questione perché il centro della vita attiva è stato, fino a qualche anno fa, presidiato da generazioni molto consistenti. In particolare i nati attorno a metà anni Sessanta (all’apice del baby boom) avevano 35 anni nel 2000, 45 nel 2010 e 55 nel 2020. Gli effetti della denatalità sull’economia e sulla sostenibilità del sistema di welfare cominciano a prodursi ora con l’entrata nelle età lavorative dei nati dalla seconda metà degli anni Ottanta in poi, quasi dimezzati rispetto alla generazione dei propri genitori. Non è più solo questione di conti pubblici, ma anche di squilibri che investono il mercato del lavoro».
Sulla demografia si gioca gran parte della competitività delle imprese. Qual è l’orizzonte temporale nel quale prevede che questo diventerà un problema insormontabile per il nostro sistema produttivo?
«L’Italia è stata il primo paese al mondo a vedere il sorpasso degli over 65 sugli under 15, avvenuto nella prima metà degli anni Novanta. Oggi la fascia più matura sta superando anche gli under 25. Secondo le stime Ocse siamo il paese che maggiormente rischia di trovarsi nel 2050 con un rapporto di 1 a 1 tra persone in pensione e lavoratori. Uno scenario di questo tipo è considerato incompatibile con qualsiasi prospettiva di sviluppo, oltre che insostenibile rispetto al sistema sociale.
Per evitare questo destino abbiamo poco tempo. La denatalità tende ad autoalimentarsi innescando un processo di avvitamento continuo verso il basso: le poche nascite passate riducono la popolazione oggi nell’età in cui si forma una propria famiglia, con conseguenti ancor meno nascite future. Detto in altre parole, a parità di figli per donna diventa più basso il numero di nascite per la riduzione continua delle potenziali madri. Più si aspetta, quindi, più diventa difficile uscire da tale spirale negativa e invertire tale tendenza.
Le nascite in Italia sono scese da oltre 550 mila nel 2010 a 420 mila nel 2019. La pandemia ha contribuito poi a farle scendere ulteriormente sotto 400 mila. Secondo lo scenario mediano dell’Istat, pur contemplando un aumento del numero medio di figli per donna, nei prossimi anni le nascite a malapena tornerebbero a 420 mila per poi ridursi continuamente senza più invertire la tendenza negativa. L’aumento della fecondità non sarebbe in questo caso in grado di bilanciare la riduzione della popolazione in età riproduttiva (le potenziali madri).
Nel percorso, invece, più ottimistico tra quelli delineati dall’Istat, le nascite tornerebbero a posizionarsi sopra 500 mila. Un obiettivo, quindi, ancora possibile ma solo se l’inversione inizia subito e viene sostenuta in modo solido. In corrispondenza, da 1,25 il numero medio di figli per donna dovrebbe salire fino a 1,65 nel 2037 (un livello comunque sotto la Francia, attualmente attorno a 1,8). Esperienze di aumento di entità simile sono quelle della Germania passata da 1,33 del 2006 a 1,6 nel 2016 o, ancor meglio, della Svezia passata da circa 1,5 nel 1999 a oltre 1,9 nel 2009. Difficile, quindi, ma non impossibile. E’, in ogni caso, l’unico percorso che ci rimane per non far scattare inesorabilmente la trappola del declino continuo delle nascite con conseguenti squilibri tra vecchie e nuove generazioni insostenibili».
Secondo lei questa problematica è sufficientemente presente nell’agenda politica?
«Per invertire la tendenza servono tre condizioni. La prima è quella di prendere piena consapevolezza del ruolo della demografia nelle sfide che ha di fronte il paese. Disinteressarsi delle dinamiche demografiche significa lasciare che gli squilibri vadano sempre più ad allargarsi con uno svantaggio competitivo crescente rispetto agli altri paesi. Con conseguente non solo diminuzione continua delle nascite ma anche scelta dei giovani di andare a vivere e a produrre benessere altrove.
La seconda è nell’approccio da adottare, che deve porre al centro dell’attenzione i meccanismi di un adeguato rinnovo generazionale. E’ il deficit di questa impostazione che porta ad indebolire percorsi e scelte delle nuove generazioni, generando una spirale negativa di “degiovanimento” quantitativo (meno giovani) e qualitativo (meno investimento pubblico su di essi, minor spinta ai processi di cambiamento del paese, minori opportunità, saldo negativo di giovani qualificati verso l’estero).
La terza condizione sta nella visione sistemica dell’azione da intraprendere. La bassa natalità è la causa degli squilibri prodotti. La ripresa delle nascite è condizione assolutamente necessaria per non vederli ulteriormente ampliare, ma la struttura per età è così compromessa che non è più sufficiente aumentare la fecondità come risposta. Per evitare lo scenario peggiore è necessario agire contestualmente su tutte le leve in modo interdipendente: quelle che operano sulle cause ma anche quelle che intervengono sulle conseguenze».
In termini di attrattività, il nostro Paese ‘perde’ ogni anno migliaia di giovani che emigrano altrove cercando soluzioni lavorative migliori. Come invertire questo trend e ‘conservare’ almeno i pochi giovani che ci sono e trattenerli nel Paese?
«L’obiettivo è far ripartire l’economia dopo la discontinuità della pandemia, ma favorendo processi che promuovano occupazione di qualità, in sintonia con le grandi trasformazioni in atto, in particolare sul fronte della transizione verde e digitale. Non basta investire sulla formazione del capitale umano e sulle competenze, è necessario poi saperle utilizzare e valorizzare adeguatamente. È quindi cruciale, oltre che migliorare l’efficienza dei servizi di incontro tra domanda e offerta, anche promuovere l’espansione di nuove opportunità avanzate, rafforzando la collaborazione tra sistema della ricerca e mondo produttivo.
Paradossalmente proprio la debolezza demografica delle nuove generazioni può favorire un’attenzione maggiore a ciò che esse sono portate a dare e desiderano essere anziché doversi meramente adattare (spesso al ribasso) a quello che ci si aspetta da loro. L’unica possibilità, del resto, per l’Italia di superare i limiti del passato e avviare una fase nuova di sviluppo sulla spinta delle risorse di Next Generation Eu, è quella di portare il sistema paese a riallinearsi al rialzo al meglio del contributo che le nuove generazioni possono dare in coerenza con le loro specificità (riconoscendone fragilità e potenzialità).
Più in generale, formare bene i giovani, inserirli in modo efficiente nel mondo del lavoro, valorizzarne al meglio il contributo qualificato nelle aziende e nelle organizzazioni, consente di rispondere alla riduzione quantitativa dei nuovi entranti con un rafforzamento qualitativo della loro presenza nei processi che alimentano sviluppo economico, innovazione sociale, competitività internazionale. Frenerebbe, inoltre, la loro fuga verso l’estero e li metterebbe anche nelle condizioni di realizzare in modo più solido il loro progetti di vita, con conseguenze positive sulla formazione di nuovi nuclei familiari e sulla natalità».
C’è, secondo lei, uno strumento che nel breve o nel medio termine potrebbe agire in termini correttivi e invertire la rotta della demografia?
«L’Italia è entrata in una fase in cui oltre ad aumentare la popolazione anziana andrà anche a diminuire la popolazione in età attiva, in modo più accentuato rispetto alle altre economie avanzate. La riduzione delle persone in età lavorativa influisce negativamente sulla crescita dell’economia, oltre che sulla sostenibilità del sistema di welfare pubblico. Dal punto di vista quantitativo i margini su cui agire per contenere tale riduzione sono le dinamiche della natalità nei prossimi anni e quelle dei flussi migratori. Ma un fronte di risposta è anche quello dell’aumento dei tassi di occupazione, soprattutto dove attualmente sono particolarmente bassi rispetti agli altri paesi (in particolare tra gli under 35 e tra le donne). Politiche del lavoro e di sviluppo che promuovono l’aumento dell’occupazione dei giovani e delle donne vanno però realizzate in modo integrato con le politiche familiari. Le misure che rafforzano l’autonomia e la transizione scuola-lavoro hanno ricadute di breve periodo sull’occupazione dei giovani oltre che favorire la formazione di nuovi nuclei familiari e quindi la natalità, che a sua volta riduce gli squilibri futuri. Lo stesso vale per le politiche di conciliazione tra lavoro e famiglia, come gli asili nido, che favoriscono nell’immediato l’occupazione delle donne con figli ma anche la scelta di avere figli per le donne occupate.
Sulla demografia, si innesta anche un’altra tematica, che è legata alle ondate migratorie. Secondo lei, da tecnico, quanto le migrazioni sono in effetti un fenomeno che sopperisce alla saldo negativo della demografia?
«Al di là della gestione dell’emergenza e delle preoccupazioni sulla sicurezza, fatica a trovare spazio nel dibattito pubblico un confronto evoluto e strategico su come l’immigrazione possa contribuire a rispondere agli squilibri demografici e al fabbisogno del nostro sistema produttivo. La prospettiva di trovarsi con un numero sempre maggiore di pensionati, bisognosi di assistenza sanitaria e, allo stesso tempo, con una riduzione della popolazione nelle età in cui si produce ricchezza, benessere e innovazione, impone la necessità di valorizzare pienamente la presenza dei giovani nel mondo del lavoro, come base di una lunga vita attiva, ma anche di attrarre persone che rafforzino, a tutti i livelli, i settori con carenza di manodopera.
Se da un lato, l’immigrazione è un fattore rilevante per rispondere agli squilibri demografici e rafforzare le capacità di sviluppo del paese, d’altro lato non è possibile un’attrazione di qualità senza sviluppo economico e possibilità di integrazione lavorativa e sociale. Inoltre, sia lo sviluppo economico, che l’integrazione lavorativa e sociale degli immigrati, rimangono deboli se non migliorano contestualmente anche le prospettive di occupazione giovanile e femminile. Ciò che oggi non funziona nella transizione scuola-lavoro, penalizza anche (spesso ancor più) i giovani stranieri. Analogamente le carenze degli strumenti di conciliazione tra lavoro e famiglia, vincolano al ribasso la partecipazione femminile al mercato del lavoro sia delle donne autoctone che delle immigrate.
Senza una politica attrattiva adeguata, integrata con il modello sociale e coerente con le strategie di sviluppo del Paese, arriverà solo immigrazione di bassa qualità, mentre gli stranieri più qualificati e con maggiori potenzialità di impiego sceglieranno altri paesi in Europa.
[1] ‘Storia demografica d’Italia. Crescita, crisi e sfide’ (con R. Impicciatore, Carocci editore, 2022)
Federico Di Bisceglie
Dopo gli studi classici approda alla redazione de il Resto del Carlino di Ferrara, appena diciottenne. Nel giornale locale, inizialmente, si occupa di quasi tutti i settori eccetto lo sport, salvo poi specializzarsi nella politica e nell’economia. Nel frattempo, collabora con altre realtà giornalistiche anche di portata nazionale: l’Avanti, l’Intraprendente e L’Opinione. Dal 2018 collabora con la rivista di politica, geopolitica ed economica, formiche.net. Collaborazione che tutt’ora porta avanti. Collabora con la Confartigianato Ferrara in qualità di responsabile della comunicazione.